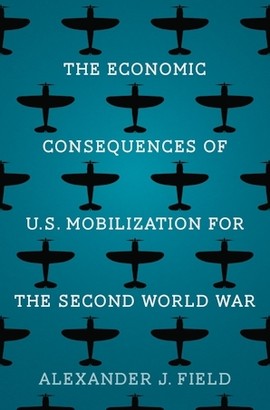Ci sono tre attitudini, a mio avviso, per approcciarsi allo studio di qualsiasi fenomeno: una costruttiva, una distruttiva e una neutrale. Alcuni si pongono il problema del proprio oggetto di ricerca in maniera costruttiva, cioè nell’ottica di elevarlo in maniera trasformativa e rivolta al futuro; poi ci siamo noi distruttori, che amiamo piuttosto la scomposizione, la frantumazione dell’oggetto per illustrarne i lati nascosti, oscuri e problematici. Infine ci sono quelli che non si pongono necessariamente la questione di che farsene dell’oggetto, ma lo scrutano, talvolta con curiosità e talaltra con fare più burocratico, per quanto mossi da genuino interesse conoscitivo. Mi sono autodenunciato, sono un frantumatore, riesco più facilmente a vedere quello che non funziona rispetto a ciò che invece va. Elena Granata, di cui ho avuto il piacere di leggere Placemaker. Gli inventori dei luoghi che abiteremo (Einaudi, 2021) è invece chiaramente una costruttrice. Appartiene dunque al primo mondo, quello di chi si pone questioni intellettuali col fine esplicito di migliorare l’esistenza futura a chi verrà dopo di noi.
Non sono necessariamente orgoglioso della mia attitudine, e chissà come si trova l'autrice nella sua, ma penso che entrambe queste attitudini riflettano tanto una sorta di indole personale quanto il tipo di educazione che uno o una ha ricevuto. Il tema dell’educazione, della pedagogia, pervade con forza tutto il volume in oggetto ed è, alla fine, il lascito più potente che porto a casa da questa lettura. Procediamo però con ordine.
Contrariamente alla definizione convenzionale di place-making, che la vede come quella pratica di trasformazione dei luoghi tipicamente neoliberale che li valorizza prima di tutto economicamente, il Placemaker che ha in mente Granata è una persona che, indipendentemente dalla formazione, si pone genuinamente la questione di come trasformare in meglio il mondo in cui vive. La spinta non è dunque la semplice valorizzazione economica, che pure può essere un motore, ma più che altro l’idea del futuro, del lascito, di quello che una volta chiamavamo con più speranza, l’avvenire.
Lo sguardo da urbanista di Granata le consente di vedere essenzialmente molto progetto architettonico e urbanistico, la spinge ad esplorare quello spazio in-between che è terreno del design urbano, ma sempre in dialogo con una lettura umanista della trasformazione
Il mondo che ci circonda è un mondo urbano, con un’impronta antropica crescente e devastante, e dunque il Placemaker si pone essenzialmente delle questioni urbane, cioè di relazione tra il costruito e l’abbandonato, l’abitato e il disabitato, il denso e il vuoto, il progetto e l’uso routinario. Quella densa relazione che Henri Lefebvre aveva identificato come il conçu, il perçu e il vecu, il concepito, il percepito e il vissuto. Più che di competenza dunque, è una questione di sguardo, di saper osservare cosa non sta (più) funzionando nella nostra relazione con uno spazio che abbiamo ereditato e di come porvi rimedio. Troviamo decine di esempi che l’autrice illustra con grazia e ottima penna, dagli amministratori di Viganella, in Valle Antrona, che per supplire all’assenza di luce naturale nel proprio paese, riescono a far installare uno specchio di 40mq per risolvere il problema, passando per le piazze auto-allaganti di De Urbanisten che interpretano in maniera davvero originale il tema dell’acqua e delle inondazioni, o l’asilo che Mario Cucinella ha progettato a Guastalla finalmente riaprendo il dialogo tra disegno e pedagogia. Lo sguardo da urbanista di Granata le consente di vedere essenzialmente molto progetto architettonico e urbanistico, la spinge ad esplorare quello spazio in-between che è terreno del design urbano, ma sempre in dialogo con una lettura umanista della trasformazione.
La proposta umanistica è dunque il filo rosso del libro. L’idea, in fondo, è che gli esseri umani possano migliorare il mondo a patto di apprendere continuamente e per fare questo devono essere messi in condizione di farlo. Quali sono dunque queste condizioni? Granata si avvicina molto al Sennett di Costruire e Abitare (Feltrinelli, 2020) nella misura in cui non intende pre-determinare l’apprendimento sotto forma di nozioni o di tecnicismi, di discipline o di saperi precostituiti. L’immaginazione, l’apertura al valore positivo dell’ignoranza, il rifiuto delle battaglie sterili o dei conflitti logoranti, la spinta alla connessione e allo scambio nutrono tutto il volume sia come esempi sia come afflato progettuale. Molta attenzione viene messa sulla dimensione di genere, ripercorrendo il dibattito sulla città femminista, e forse ancora di più sulla dimensione generazionale, in un dialogo aperto sia con i suoi studenti, sia con la sua famiglia e le diverse generazioni di cui è composta. È dunque anche un testo molto personale, dove il lettore passa dall’aula dove Granata cerca di pensare a nuove forme di coinvolgimento didattico, alla dimensione più familiare e domestica dell’autrice.
Ora, noi cinici e spietati distruttori d’oggetti non ci lasciamo necessariamente sedurre interamente da questa visione, perché subodoriamo sempre una fragranza post-politica. Non si parla infatti delle nostre amate disuguaglianze sociali, o comunque non come noi ce lo aspetteremmo. Non ci sono classi sociali, quindi nemmeno la lotta tra di esse, e persino il potere sembra evaporare assieme alle molteplici responsabilità politiche che ci hanno consegnato questo pianeta così bello eppure così problematico. Molti esempi che vengono trattati in questo libro, sono oggetto dei nostri strali più impetuosi. Tra tutti, il caso della High Line newyorchese pensata da Diller e Scofidio: sono almeno quattro anni che ne faccio una parte monografica del mio corso sulla gentrification, dove ragiono con i miei studenti sugli effetti disastrosi prodotti dallo spazio pubblico neoliberale. Eppure, ammetto di aver più d’una volta tentennato nelle mie granitiche convinzioni, davanti alla calma olimpica con cui Granata ha liquidato mostri sacri come Koolhaas, reo di una visione cinica e mercatista dell’urbano, ha archiviato dibattiti tanto vuoti quanto pervasivi come quelli sulla rinascita dei borghi (per sé) o ha coraggiosamente asfaltato (mi si perdoni) l’ideologia conservatrice e reazionaria che si cela dietro la difesa a tutti i costi del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano. Per non parlare del dialogo serrato tra l’autrice e la sua città, Milano, cui sono dedicate molte pagine dense e rigorose.
Quindi è un libro coraggioso, forte, direi quasi gandhiano.
La forza della proposta dell’autrice è soprattutto nel non scaricare sugli altri la responsabilità di un cambio di passo necessario e non più rinviabile nel progetto del futuro
Chiudo però sulla riflessione pedagogica, che mi sembra davvero «la»ci questione che Granata interroga con questo volume: la forza della proposta dell’autrice è soprattutto nel non scaricare sugli altri la responsabilità di un cambio di passo necessario e non più rinviabile nel progetto del futuro. I Placemakers sono ovunque, e si muovono, esistono, indipendentemente dalla nostra azione o volontà, ma è chiaro che chi occupa delle posizioni nel sistema formativo non può continuare a chiamarsi fuori da una responsabilità collettiva nei confronti del pianeta e delle sfide, soprattutto ecologiche, che ci pone. Granata su questo punto è chiara e convincente: dobbiamo avere il coraggio di ripensare la didattica, l’esistenza stessa delle nostre discipline, in chiave trasformativa. Dobbiamo partire da ciò che non sappiamo, coinvolgere i nostri studenti in questo sforzo, saperli ascoltare e credere nelle risposte che già ci danno perché, come molti di noi hanno capito da tempo, sono realmente la parte migliore e più viva dell’istituzione universitaria.
Davanti a questa proposta, il mio cinismo vacilla e, infine, crolla. Ha ragione Elena Granata, dobbiamo rimboccarci le maniche e lasciarci alle spalle rapidamente il mondo che abbiamo ereditato. Il futuro va pensato, prima e meglio possibile, perché comunque avverrà e ci presenterà il conto.

Riproduzione riservata