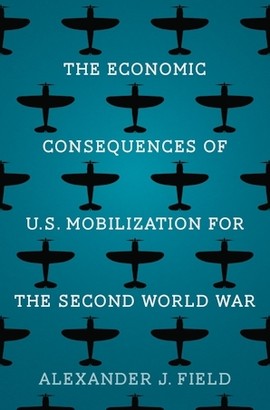La questione della valutazione secondo criteri meritocratici – esibiti, applicati, abusati a seconda dei casi e delle opinioni – riaffiora di tanto in tanto nel dibattito pubblico italiano, per lo più in forma strumentale. Una felice eccezione è il volume di Mauro Boarelli, Contro l’ideologia del merito (Laterza, 2019), che in modo organico affronta il passaggio del merito da elemento morale (così come declinato ad esempio nella Costituzione italiana: vedi i famosi “capaci e meritevoli” dell’art. 34) a espressione apparentemente asettica del potere.
Secondo Boarelli, l’origine di questa torsione in senso ideologico nasce nei primi anni Novanta, sulla scorta di una letteratura economica e tecnocratica assillata dagli standard e dalle misure: è allora che osserviamo lo slittamento dalle conoscenze alle competenze (poi divenuto mainstream anche in ambito umanistico) e l’enfasi posta sulla flessibilità, sull’orientamento alla risoluzione dei problemi, con conseguente e progressiva riduzione della valutazione a espressioni via via sempre più schematiche e decontestualizzate: i test. Boarelli ha buon gioco nel dimostrare, sulla scorta di un’appropriata bibliografia, in che modo i test, più che verificare, orientino fortemente i processi di apprendimento; ma è vero che ciò forse vale per tutti gli strumenti di verifica, anche quelli in apparenza meno formalizzati. “Capitale umano, competenze e valutazione standardizzata” sono i termini che esprimono da ormai molto tempo il verbo dell’ideologia meritocratica, rendendo epidemici l’efficienza, la misurazione della performance, ecc.
Boarelli aggiunge a questa lettura una chiosa importante: la creazione di una burocrazia della valutazione – terza rispetto agli attori impegnati nelle azioni da misurare e detentrice delle progressioni di carriera o delle risorse – finirebbe per costituire una nuova élite dominante. La forza di tale élite consisterebbe nella capacità di poter valutare qualsiasi contesto in base ai già ricordati parametri del verbo meritocratico, indipendentemente dai contenuti. Anzi: il cuore del lavoro amministrativo si sposterebbe dalla logica funzionale propria di qualsiasi istituzione, pubblica o privata, al controllo formale, produttore, nell’organizzazione, di una centralità (di potere) sostanziale. Mi viene in mente un passo ironico di Una visita guidata di Alan Bennet (Adelphi, 2008, pp. 41-42):
“Ma come capita alla maggior parte delle istituzioni pubbliche, oggi non viene chiesto alla National [Gallery] soltanto di fare il suo lavoro, ma di dimostrarlo. È una pretesa controproducente, che crea un circolo vizioso. L’ortodossia corrente ritiene che gli impiegati pubblici facciano il loro lavoro al meglio solo se gli viene chiesto di dimostrare che stanno facendo il loro lavoro al meglio; ma questa dimostrazione richiede tempo, e quello speso a preparare le relazioni annuali e i piani aziendali che dimostrano che ciascuno sta facendo il proprio lavoro è tempo sottratto alle ore di lavoro… e il risultato è che l’istituzione è effettivamente meno efficiente di quel che potrebbe essere. Che è esattamente ciò che sta cercando di dimostrare il ministero del Tesoro”.
Dopo aver seguito con divertimento il ragionamento di Boarelli fino alla ritualità del linguaggio performativo, all’autoritarismo strisciante che esso nasconde, all’ipocrisia della koinè burocratica, all’anestesia praticata nel corpo sociale – attraverso diversi soggetti “terapeuti” – per sedare i conflitti, mi sono venute in mente un paio di domande. E prima? Prima del predominio dell’ideologia del merito (dagli anni Ottanta-Novanta), come avveniva la selezione? Era razionale, equilibrata, attenta alla stima effettiva delle conoscenze? O il mondo dei “trenta gloriosi”, quello del trentennio del grande sviluppo occidentale, ci sembra a posteriori migliore solo perché, sulla spinta determinata dall’ascesa sociale di milioni di persone, il merito è stato nobilitato dall’emancipazione di tanti figli dei ceti subalterni? Proviamo a pensare a ciò che accadeva, anche solo in Italia, nell’età liberale o nell’età giolittiana: una durissima selezione meritocratica, legittimata a livello popolare dal senso comune selfhelpista, conviveva con un largo clientelismo, fianco a fianco.
Condivido quindi l’analisi della torsione ideologica della meritocrazia, ma non credo che, in sé, essa sia sbagliata. È probabilmente giusto, ad esempio, prendersela, in ambito universitario, per gli “eccessi di misura” di Anvur, ma l’autocefalia irresponsabile di prima non è che avesse prodotto esiti brillanti, anzi. Dal discorso di Pericle nelle Storie di Tucidide in poi, la democrazia è composta dall’uguaglianza di fronte alla legge e da “una scala di valori fondata sulla stima che ciascuno sa suscitarsi intorno, per cui, eccellendo in un determinato campo, può conseguire un incarico pubblico, in virtù delle sue capacità reali, più che dell’appartenenza a questa o a quella fazione politica” (Storie, II, 37). Non abbiamo molti altri modelli alternativi, né il volume in oggetto ne formula: la pars destruens risulta quindi, come spesso accade, assai più efficace e meglio argomentata della construens. Dopodiché, credo che un approccio come quello di Boarelli sia utile per più motivi: in primo luogo, perché la burocratizzazione della valutazione e la giuridificazione dei rapporti sociali che si celano dietro la “tecnica della misura” non muovono affatto in direzione di una maggiore efficienza, ma di un appesantimento continuo del processo selettivo, che contrasta vistosamente con l’imperante presentificazione, scandita viceversa dal trionfo (retorico) della velocità decisionale. Il cortocircuito generato da questi due fenomeni post-moderni pare evidente nel motore imballato di tutte le istituzioni chiamate a produrre politiche.
In secondo luogo, perché effettivamente rivela l’esistenza, all’interno del ceto burocratico, pubblico o privato, di un nuovo mandarinato, quasi una super-classe votata, attraverso le tecnologie meritocratiche, a costruire una propria autonoma filiera di carriera e di potere, a scapito delle funzioni orientate al servizio, al prodotto, al processo. Potrebbe essere studiata come nuovo soggetto sociale: sarebbe una bella ricerca. Ciò detto, forse il problema principale, dopo tante riflessioni sulle retoriche del merito e sulle ideologie del merito, è quello di restituire il merito alla sua autentica vocazione, che è morale oltre che scientifico-tecnico-culturale. Ragion per cui, per consacrare a questo momento decisivo il tempo e la ponderazione che merita, verrebbe da dire, almeno come sommesso suggerimento: “Valutare meno, valutare meglio”.

Riproduzione riservata