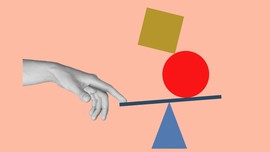La possibilità di chiamare gli elettori alle urne per un secondo voto sul recesso dall’Unione europea era stata paventata già all'indomani del 23 giugno 2016, quando più di 4 milioni di cittadini avevano sottoscritto una petizione al Parlamento in cui chiedevano la convocazione di un secondo referendum a causa del mancato raggiungimento di un livello minimo di partecipazione (il 75% degli aventi diritto) e di una maggioranza qualificata (il 60% dei consensi) a favore di una delle due opzioni in campo. D'altra canto, poiché nessuna delle due condizioni era prevista dalla legge che ha disciplinato la consultazione popolare (European Union Referendum Act 2015), nel dibattito che si è svolto in Parlamento il governo ha correttamente rilevato che le operazioni referendarie si erano svolte nel pieno rispetto della legge.
Un anno più tardi, dopo le elezioni anticipate del 2017, Vernon Bogdanor ha riaperto la questione sulle pagine del «The Guardian», usando la leva della composizione del nuovo Parlamento. Una Camera dei Comuni dove i laburisti sono più forti e i conservatori sono deboli al punto da dover ricorrere all’appoggio esterno del Dup nord-irlandese per sostenere il governo e una Camera dei Lord dove esiste un consistente fronte pro «remain» renderebbero particolarmente complessa l’approvazione parlamentare dell’accordo con l’Unione, tanto da chiamare in causa l’appello al popolo per legittimare l’atto finale e superare ogni possibile impasse istituzionale. Tony Blair ribadisce il diritto del popolo britannico di essere interpellato sull'esito delle trattative con l'Unione europea. L’idea è che il corpo elettorale scelga tra la membership e il recesso dopo la conclusione delle trattative Il 4 gennaio Tony Blair ha rilasciato un'intervista nella quale ribadisce il diritto del popolo britannico di essere interpellato sull'esito delle trattative con l'Unione europea. L’idea è che il corpo elettorale scelga tra la membership e il recesso dopo la conclusione delle trattative che definiranno il futuro rapporto tra l’isola e il continente. Sembrerebbe una proposta ragionevole se non fosse che quando il popolo si è pronunciato sulla Brexit nel campo del «remain» militava la certezza dell’appartenenza, mentre in quello del «leave» militava l’incertezza sul futuro dei rapporti con l’Europa. Si potrebbe quindi obiettare che di quella incertezza gli elettori si siano già fatti carico nel giugno del 2016.
Pochi giorni dopo, sul fronte opposto, Nigel Farage, vincitore morale della prima tornata referendaria ed ex leader dello Ukip, ha auspicato una nuova convocazione delle urne, affinché la questione sia definitivamente chiusa da una seconda vittoria del «leave». Farage fa bene a rilevare provocatoriamente che un voto popolare c’è già stato, ma omette di riconoscere che il voto del 2016 non ha chiuso la questione del rapporto con l’Europa, ancora in grado di «scaldare» gli animi di entrambi gli schieramenti, poiché non sempre i referendum sono in grado di tagliare il nodo di Gordio di fronte al quale sono chiamati.
In punta di diritto nulla vieta al Parlamento di approvare una legge che introduca la convocazione di una seconda tornata referendaria: nel Regno Unito, infatti, non esiste una disciplina generale del referendum, con la conseguenza che ogni consultazione è stata finora convocata e regolata da una legge ad hoc. Tuttavia, un secondo appello al popolo appare problematico da molteplici punti di vista e rischia di aprire più questioni di quante non potrebbe chiuderne.
La prima attiene al rapporto tra i due voti in relazione alla definizione dei quorum di partecipazione e di deliberazione e ai confini dell’elettorato attivo. Si tratta di aspetti criticati nella prima tornata referendaria che sarebbe preferibile non siano replicati, ma che – ove «corretti» – solleverebbero il tema della «omogeneità» tra i due voti e possibili contestazioni dell’esito del secondo.
La seconda concerne il rischio di riproporre il corto circuito tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta che si è innescato nel giugno 2016 e che in questi mesi il sistema politico e quello istituzionale hanno faticosamente tentato di riparare. Brexit ha portato alla luce una profonda distanza tra il popolo e i suoi rappresentanti[1], una frattura che ha sollevato non pochi dubbi sulla condotta di voto dei parlamentari. Tuttavia i due principali partiti si sono impegnati nel dare seguito alla volontà popolare e i parlamentari hanno finito per adeguarsi al vincolo politico risultante dal referendum. In questa prospettiva il Parlamento ha approvato a larga maggioranza la legge che ha autorizzato il governo a notificare al Consiglio d’Europa l’intenzione di recedere dall’Unione (il Notification Withdrawal Act 2017 è stato approvato nel testo proposto dal governo in terza lettura con il voto favorevole di 499 deputati e contrario di 122; 8 febbraio 2016, divisione n. 161).
Ora, se un referendum convocato dopo la chiusura delle trattative confermasse la vittoria del «leave», saremmo – politicamente parlando – nella scia di quanto è accaduto dal giugno 2016 a oggi, ma cosa accadrebbe se il corpo elettorale rigettasse l’accordo concluso con l’Unione europea? Potremmo dire di trovarci di fronte a un riallineamento di indirizzi tra il popolo e i suoi rappresentanti, se non fosse che dal giugno 2016 governo e Parlamento hanno agito in direzione opposta e contraria. Non certo un toccasana per le istituzioni democratiche.Una volta che l’intenzione di recedere è notificata, il termine dei due anni inizia a decorrere e le trattative con l’Unione saranno o in pieno svolgimento o chiuse, lo Stato membro avrà la possibilità di bloccare unilateralmente l'intero processo?La domanda, peraltro, non interessa solo il rapporto tra volontà popolare e volontà parlamentare, ma anche la conclusione del processo di recesso e i rapporti con l’Europa. L'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea riconosce agli Stati membri il diritto di attivare il recesso, ma una volta che l’intenzione di recedere sia stata notificata, il termine dei due anni ha iniziato a decorrere e le trattative con l’Unione sono in pieno svolgimento o si sono chiuse, lo Stato membro ha la possibilità di bloccare unilateralmente l'intero processo? Ricordo che le sentenze dell’Alta Corte e della Corte Suprema che hanno chiarito quale dovesse essere il ruolo del Parlamento nell’avvio del processo di recesso hanno fondato le proprie conclusioni partendo dall’assunto che la notifica fosse un atto irrevocabile (R (Miller) v SS for Exiting the European Union [2016] EWHC 2768 e R (Miller) v SS for Exiting the European Union [2017] UKSC 5). Il punto è controverso, ma c’è il rischio il popolo sia convocato per una decisione che non è certo possa assumere.
Brexit ci ha insegnato che l’esercizio del diritto di voto può riservare grandi sorprese, con la conseguenza che il ricorso alle urne rischia di trasformarsi in un boomerang per chi pensa di poter utilizzare la volontà popolare al servizio di un obiettivo politico. Sembrerebbe dunque preferibile partire dalla constatazione secondo cui il popolo ha già parlato e il resto di questa difficile partita è ora in mano alle care e vecchie istituzioni rappresentative.
[1] Prima del voto di giugno 479 deputati si erano schierati a favore del «remain» (fra i quali 185 conservatori, 218 laburisti, 54 indipendentisti scozzesi, 8 liberal-democratici, 4 deputati del Sinn Fein, 3 del Plaid Cymru e 4 del Social Democratic and Labour Party) a fronte dei 158 posizionati a favore del «leave» (fra i quali 138 conservatori, 10 laburisti e 8 deputati del Democratic and Unionist Party). Come è noto, invece, al voto di giugno ha preso parte il 72,2% degli aventi diritto: il 51,9% degli elettori (17.410.742) si è espresso a favore del «leave» e il 48,1% (16.141.241) a favore del «remain». V. http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35616946.

Riproduzione riservata