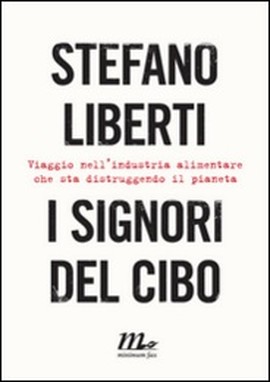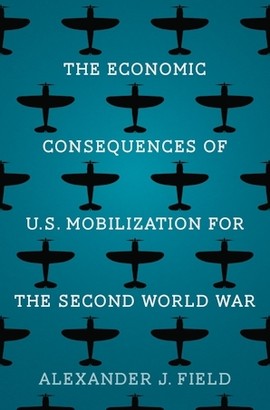Nel 1906 Upton Sinclair, giovane giornalista con simpatie socialiste, pubblicò The jungle (trad. it. La giungla, Il Saggiatore, 2003, a cura di Mario Maffi), romanzo-inchiesta su Packingtown, l'enorme quartiere dei macelli di Chicago, in cui un gran numero di fabbriche – controllate da un potentissimo «trust della carne» – impiegavano decine di migliaia di operai nella trasformazione di carne proveniente da tutti gli Stati Uniti e poi commercializzata in tutto il mondo. Protagonista del romanzo è una famiglia di immigrati lituani appena arrivata negli Stati Uniti, che in pochi mesi viene distrutta fisicamente e moralmente dal lavoro e dalla vita a Packingtown (solo uno di loro si salverà, approdando al socialismo). Quello che però fece più scalpore di quel libro (presto diventato un classico della letteratura americana) fu la descrizione delle pratiche di macellazione e inscatolamento, vividamente descritte nel libro sulla base delle minuziose indagini di Sinclair: pratiche guidate dalla pura ansia del profitto ed estremamente pericolose per la salute dei consumatori. In pochi mesi, lo scandalo suscitato dal libro portò il Congresso a emanare due leggi per regolamentare l’industria alimentare (mentre le condizioni dei lavoratori non furono oggetto di particolare attenzione).
Centodieci anni dopo, l’inchiesta I signori del cibo, di Stefano Liberti (Minimum Fax, 2016), si apre con la descrizione dell’industria della carne di maiale tra gli Stati Uniti e la Cina. Come Sinclair, Liberti osserva le fasi della macellazione in enormi stabilimenti, diventate molto più ordinate, sicure, asettiche (per quanto possa esserlo l’uccisione di esseri viventi). Eppure, l’impatto della grande industria alimentare sul pianeta appare ancora più terribile rispetto ai primi del Novecento. In enormi allevamenti chiamati Cafo (Concentrated Animal Feeding Operations) viene allevata una enorme quantità di maiali nel più breve tempo possibile; le zone circostanti sono sommerse da estesi laghi di raccolta degli escrementi dei maiali, estremamente inquinanti a causa delle massicce dosi di antibiotici e ormoni iniettati agli animali, e che rendono impossibile la vita degli esseri umani nei dintorni. Altra novità rispetto a Sinclair: Liberti osserva non solo i macelli statunitensi, ma anche e soprattutto quelli cinesi. La più grande azienda produttrice di carne al mondo è infatti una multinazionale cinese che nel 2013 ha acquistato – con il supporto del governo cinese e di attori finanziari come la Goldman Sachs – la sua diretta concorrente statunitense.

I signori del cibo, seguito ideale di un’altra importante inchiesta di Liberti, Land Grabbing (Minimum Fax, 2011), è un impressionante viaggio globale che indaga e denuncia gli effetti della grande industria alimentare, della finanziarizzazione dell’agricoltura e del commercio globale di cibo. Oltre alla filiera del maiale, Liberti descrive quella della soia, gestita da poche multinazionali che hanno ridotto il Mato Grosso brasiliano a milioni di ettari di monocoltura da esportazione, proprio per nutrire i maiali cinesi; quella del tonno, una specie che si avvia rapidamente all’estinzione; quella del pomodoro da industria, che porta ancora in Cina, ma anche in Ghana e nel Sud Italia delle baraccopoli e del caporalato.
I signori del cibo è documentato, rigoroso e piacevole da leggere. Si basa su un lavoro di anni, su un gran numero di interviste e visite a stabilimenti e piantagioni e utilizza molte ricerche accademiche. Fa nomi e cognomi. La tesi principale è che «L’inedita alleanza tra grandi gruppi alimentari e fondi finanziari ha portato allo sviluppo di quelle che definisco aziende-locusta: gruppi interessati a produrre su larga scala al minor costo possibile, che stabiliscono con l’ambiente e con i mezzi di produzione – la terra, l’acqua, gli animali d’allevamento – un rapporto puramente estrattivo. Tali ditte hanno come unico orizzonte il profitto […]. E sfruttano le risorse in modo intensivo, fino al loro totale dissipamento» (pp. 8-9). Il tutto con l’appoggio o la compiacenza dei governi e con l’aiuto di accordi internazionali di libero scambio.
A patire di tutto questo sono in primo luogo le popolazioni locali, dall’Africa al Brasile, dagli Stati Uniti alla Cina: spossessamento dei terreni, impoverimento delle risorse, inquinamento devastante (e, in Brasile, deforestazione), distruzione delle agricolture contadine tradizionali, spinta all’emigrazione e all’urbanizzazione di masse provenienti dalle aree rurali. E patiscono i consumatori, «noi consumatori, costretti a nutrirci di cibi sempre più standardizzati, prodotti in modo industriale e a costi infimi […] senza tenere in nessun conto i costi sociali, ambientali e culturali che sul medio periodo saremo costretti a pagare» (p. 317).
Manca credo nel libro una riflessione sul ruolo che ha un altro tipo di attore, oggi centrale nel commercio globale del cibo, e cioè le grandi catene di supermercati: Wal-Mart, Carrefour, Tesco e compagnia hanno dimensioni paragonabili e a volte superiori a quelle delle multinazionali citate da Liberti (Cargill, Monsanto, Shanghui, Mitsubishi…). Esse, come le grandi catene di fast food, sono un ineludibile alleato delle «aziende-locusta» nella logistica della distribuzione del cibo, nella ricerca di profitti dall’agricoltura e nella marginalizzazione dei piccoli produttori.
Ma, al di là di questo, e al di là dell’indignazione che questo libro suscita in tutti i lettori, vorrei prendere sul serio l’appello di Liberti al dibattito, un «dibattito sempre più urgente sotto la spinta della sovrappopolazione e dei cambiamenti climatici». Ebbene, il limite principale de I signori del cibo mi pare un limite politico. Liberti intervista e riporta le parole non solo dei dirigenti delle multinazionali, ma anche di numerosi attivisti che a esse si oppongono: associazioni anti-Cafo in North Carolina, fattorie biologiche vicino Pechino, militanti ambientalisti a Manaus, piccoli pescatori in Senegal e California. Di tutti costoro descrive contraddizioni e difficoltà; ad esempio, nota giustamente come produzioni di nicchia, costose e riservate ai ricchi, non possano costituire un’alternativa realistica. Ho trovato però troppo frettoloso il modo con cui liquida uno dei suoi interlocutori brasiliani, Joao Pedro Stedile, portavoce del Movimento Sem Terra: Liberti dice di condividere la sua analisi, ma infine bolla la sua idea di sovranità alimentare basata sulle agricolture contadine come «una specie di anacronismo romantico», mentre il mondo «sta andando da un’altra parte» (pp. 143-44). Mi pare poco rispettoso e poco utile giudicare in questo modo un’organizzazione che conta milioni di contadini e braccianti in Brasile ed è parte della Via Campesina, forse il più grande movimento al mondo. Il movimento che con più forza si oppone al sistema così ben descritto da Liberti, anche perché da quel sistema i contadini dei Paesi poveri sono direttamente minacciati.
Ecco, i principali interlocutori di Liberti sembrano essere invece i consumatori occidentali, noi consumatori. Ma a essi non riesce a proporre direzioni e alleanze per costruire un’alternativa a questo terribile sistema di produzione e commercio del cibo, se non in relazione a una maggiore consapevolezza rispetto ai consumi. The jungle, nel 1906, ebbe un effetto politico immediato, anche se parziale. Mi pare difficile che, appellandosi solo al consumo, I signori del cibo possa sortire effetti analoghi.

Riproduzione riservata