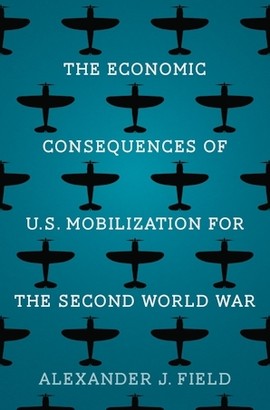Nel 1816, a ventidue anni dalla morte di Beccaria, il figlio Giulio allestì un’intera sala del palazzo milanese di via Brera per custodire i manoscritti di Cesare e le varie edizioni dei suoi scritti: un piccolo santuario domestico eretto alla memoria del padre. Quali sovrapporte agli ingressi della sala, Giulio commissionò a un ignoto pittore quattro tele allegoriche dipinte a tempera in grisaille, a effetto bassorilievo. Mentre le ultime due sono dedicate alle lezioni di economia impartite da Beccaria dal 1769 al 1772, le prime due illustrano l’evento più memorabile della sua vita: la stesura, dalla prima bozza del 1763 all’ultima edizione del 1766, del libro Dei delitti e delle pene.
La prima tela raffigura il momento immediatamente anteriore alla scrittura: quello dell’ispirazione civile. La Giustizia, velata e in ceppi, con aria affranta, è presentata da un Genio alato a Beccaria. Questi, seduto allo scrittoio, ruota le spalle per volgere lo sguardo verso di loro. Lo spettatore conosce l’effetto di questa visione: l’uomo seduto alzerà la sua voce per restituire dignità alla giustizia. Eccolo allora, nell’immagine della seconda tela, intento a scrivere il suo capolavoro. A dettarglielo è Minerva: cioè, il lume della ragione.
Nella grazia neoclassica della prima tela colpisce il volto chino e mesto della Giustizia. Ha le mani legate: è impotente, asservita. La sua condizione segna il trionfo dell’ingiustizia. Colpiscono, però, anche gli oggetti che stanno ai piedi della sua dimessa figura: un ceppo, strumento del boia, funzionale alla decapitazione; e una spada, tradizionale attributo della Giustizia insieme alla benda e alla bilancia (che non compaiono, tuttavia, nella tela commissionata da Giulio Beccaria). Che significato ha la presenza di questi oggetti?
La Giustizia è afflitta e impotente proprio perché le viene affidata la cruenta incombenza di tagliare la testa ai condannati: giustiziare è un’ingiustizia
L’idea del pittore (o del suo committente) è probabilmente che la Giustizia è afflitta e impotente proprio perché le viene affidata la cruenta incombenza di tagliare la testa ai condannati: giustiziare è un’ingiustizia. La spada non compare dunque nella tela quale attributo della Giustizia, bensì come la sua negazione. La Giustizia – l’autentica giustizia – si affaccia con i tratti della mitezza: è una figura disarmata. Ciò non risolve però il suo rapporto con la violenza. Contrapponendosi all’eulogia della potestas gladii, Beccaria avverte pienamente il carattere inesorabile e tragico di quel rapporto: interprete di una nuova sensibilità umanistica, approda a una consapevolezza sofferta e feconda.

Nella rappresentazione tradizionale, la spada era il fulgido emblema della giustizia che punisce la malvagità: dispositivo salvifico del potere che si oppone alla violenza. Contro questa ideologia mistificante insorge la filosofia di Beccaria. Senza dubbio, la violenza penale serve a combattere quella criminale: ma sempre violenza resta. Non c’è nulla di sacro nella violenza della pena. Perciò la sua giustizia non risiede che nella minimizzazione della violenza: la pena sarà tanto più giusta quanto meno sarà violenta. Le armi del diritto penale sono quelle della violenza; e la violenza è sempre la stessa: triste e bruta. Se compito del diritto penale è di ridurre la violenza sociale, allora anche quella legale va diminuita il più possibile. Ecco perché l’icona della Giustizia è una figura drammatica: non potendo rinunciare alla violenza, deve sempre sforzarsi di farne l’uso minimo necessario.
A questo «minimo possibile», insieme cifra stilistica e nucleo filosofico dei Delitti, è dedicato questo libro. Che significato può avere l’aggettivo giusto quando è riferito a quell’atto violento che è una pena legale? Come cercherò di mostrare, la risposta di Beccaria è espressione di un mutamento di paradigma: i Delitti affrontano la questione penale da una prospettiva nuova, con nuovi concetti.
Che significato può avere l’aggettivo giusto quando è riferito a quell’atto violento che è una pena legale?
Nel discorso di tanti specialisti circola tuttavia un giudizio diverso e sminuente: il pamphlet ammirato dai philosophes dell’Encyclopédie e dai costituenti americani sarebbe soltanto un felice mosaico di idee già formulate, in parte perfino già attuate nella pratica giudiziaria; per giunta il suo autore, avendo attinto da un vasto, eterogeneo deposito di argomenti altrui, avrebbe finito con lo sviluppare un discorso incoerente. In questo libro sostengo una tesi esattamente opposta: contrastante rispetto a quella che è diventata una vera e propria vulgata accademica. Certo, è necessario decostruire i clichés che hanno plasmato la leggenda aurea della modernità penale: Beccaria non è l’Eroe che, col senno e con la penna, alla santa ragione ridusse i suoi compagni erranti. L’intento di sfatare il mito, però, non deve portare a misconoscere l’esistenza di una svolta nella riflessione penale – quasi fosse un ingannevole miraggio, formatosi nell’illusione retrospettiva.
Il mio proposito è insomma quello di restituire a Beccaria la sua statura di classico: autore di un capolavoro innovatore, che supera la tradizione da cui attinge a piene mani, sviluppando un discorso coerente che lo rende sempre attuale. Nel contesto di una precisa battaglia politica, l’illuminista milanese ripensò i problemi del diritto penale alla luce di una personale decisione filosofica.
La sua condanna della pena capitale ne è la spia più lampante. Essa non scaturì spontaneamente da dottrine penali o filosofiche più vecchie, come un frutto già maturo che aspettava solo di essere raccolto. Emerse invece da una serie coerente di altre innovazioni filosofiche, che vanno dalla riflessione sull’agire umano alla teoria del diritto, dalla dottrina del «governo bene organizzato» al concetto di diritti umani: in breve, da una vera e propria filosofia penale, che il presente libro mira a illustrare. Le argomentazioni sviluppate nei Delitti sono del tutto nuove, perché prodotte e dedotte da un nuovo, autonomo quadro concettuale.
Il significato e la stessa realtà di questa rottura epistemologica rischiano tuttavia di sfuggirci, per due ragioni. La prima è il fatto che siamo immersi nel mondo culturale che Beccaria ha contribuito a generare: proprio per effetto del cambiamento di paradigma che le sue idee hanno provocato, non riusciamo sempre a percepire l’effettiva novità di un testo che il suo medesimo successo ha paradossalmente banalizzato. La ricostruzione del contesto e l’analisi argomentativa sono dunque indispensabili a recuperare, comprendendola meglio, l’originalità dirompente dei Delitti. In secondo luogo, talvolta Beccaria ci può sembrare contraddittorio proprio perché ha coniato concetti divenuti per noi evidenti, ma che confliggono con vecchie idee da lui ancora condivise. È dunque importante, in questo caso, rimarcare come sia stato lo stesso autore a fornirci gli strumenti teorici che lo rendono contraddittorio. In questo saggio, per evidenziare sia la novità epocale che la salda coerenza della filosofia penale di Beccaria, farò dunque ricorso allo studio del contesto teorico. Indagando le fonti di questa filosofia, cercherò di spiegare la fortuna dell’opera e di mettere in luce la sua forza: una forza sempre attuale, sempre capace di farci ripensare la questione penale.
[Questo testo è estratto da Violenza e giustizia di Philippe Audegean, appena pubblicato per il Mulino]

Riproduzione riservata