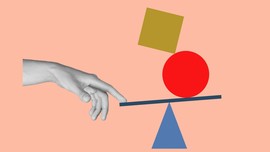Il testo della proposta di legge n. 774 («Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione del Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana») presentato, con altri, da Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia) si sovrappone in larga parte con quello (n. 678) per la verità più dettagliato, già presentato il 31 maggio del 2018 e arenatosi nelle secche parlamentari. Si tratta, insomma, di una materia da tempo ritornante nel dibattito politico e in quello culturale.
Una buona metà degli articoli di questo testo sancisce espressamente obblighi come quello di esprimersi in italiano da parte della Pubblica amministrazione, o di conoscere l’italiano da parte di chi ricopre cariche pubbliche: obblighi che non so se siano oggetto di specifiche norme già esistenti, ma fanno comunque parte di una normalità che dovrebbe discendere da pratiche comuni della vita civile. Ogni forma di selezione nella Pubblica amministrazione prevede il superamento di prove e di colloqui in italiano, se addirittura non presuppone il possesso di titoli di studio per i quali la «padronanza scritta e orale della lingua italiana» è un requisito essenziale, cosicché vien da chiedersi perché qualcuno senta il bisogno di sancire questi obblighi attraverso un’apposita nuova norma (vedremo tra poco quale potrebbe essere, in realtà, il motivo).
Multe da cinquemila a centomila euro. Addirittura. E comminate da chi, e con qual criterio?
Più interessante è il caso dell’art. 5 della proposta, che prevede una modifica dell’art. 1346 del Codice civile, cui andrebbe aggiunto l’obbligo della redazione in italiano di qualsiasi contratto di lavoro. Posto che in italiano è redatta tutta la documentazione relativa ai numerosi adempimenti necessari per un’assunzione, e che ovviamente in italiano avrebbe corso qualsiasi eventuale forma d’impugnazione o di ricorso, mi pare singolare anche solo immaginare la ricevibilità di un contratto che, stipulato in Italia, non sia formulato (almeno) in italiano. Se poi la traduzione in altra lingua si rende necessaria perché una delle parti, o entrambe sono straniere, è chiaro che ciò non toglie la necessità dell’uso dell’unica lingua in cui si esprimono l’amministrazione e la giustizia locali.
Uno degli argomenti agitati nella polemica sorta nei giorni scorsi attorno a questo testo è che proprio la Pubblica amministrazione italiana è stata spesso – e giustamente – accusata di ricorrere a un italiano smodatamente intriso di inutili anglicismi, che spesso sono disseminati senz’alcun criterio in testi ufficiali redatti in un insopportabile aziendalese.
Da questo punto, però, si diparte un bivio concettuale che raramente è messo a fuoco nei dibattiti e sembra completamente sfuggito a chi ha redatto la proposta di legge.
Una cosa, in effetti, è l’uso di parole straniere (poniamo: inglesi) in un testo scritto in una certa lingua (poniamo: in italiano). Altra cosa è la sostituzione integrale di una lingua (poniamo: l’italiano) con un’altra lingua (poniamo: l’inglese) in determinate situazioni o per determinati usi. Ad esempio: le lezioni universitarie, le pubblicazioni scientifiche o l’analisi dei mercati finanziari.
I due fenomeni sono in realtà connessi, ma hanno origine e valenza ben diverse. Il primo è semplicemente il sintomo di un deficit culturale. Chi non riesce a scrivere un testo informativo o normativo in italiano senza ricorrere ossessivamente a termini inglesi, sebbene essi siano facilmente traducibili in italiano, probabilmente è una persona che non padroneggia a sufficienza né l’italiano, né l’inglese, e perciò si avventura in una terra di mezzo nella quale l’uso di termini stranieri – non necessariamente più appropriati, come spesso osservano i madrelingua – serve soprattutto a mascherare lo scarso controllo del mezzo, e ad alzare una cortina fumogena sull’ignoranza. È, insomma, il segno di un disagio o di una scarsa dotazione culturale cui non la legge, ma semplicemente il sistema educativo – unito a un’efficace sanzione sociale – dovrebbe porre rimedio. Peggio che un crimine, un errore, da correggere piuttosto in classe che in cella.
Per contro, chi deliberatamente favorisce l’inglese ed emargina un’altra lingua (poniamo l’italiano o il tedesco) nell’espressione di determinati contenuti o in determinate situazioni o circostanze, sta semplicemente avviando le lingue rimpiazzate a una pur lenta estinazione, e sta magari inconsapevolmente depauperando il dibattito scientifico e culturale, favorendo un monolinguismo che uniforma e isterilisce.
Decidere che l’italiano – o il tedesco, o il neerlandese – non dev’essere più usato, come è avvenuto per secoli, per scrivere di fisica, di ingegneria o di biologia significa sospingere quelle lingue in un ghetto che è, obiettivamente, il primo passo verso l’emarginazione. Ogni eventuale contro-obiezione (la più facile: l’inglese favorisce l’agevole circolazione internazionale delle idee) s’infrange contro una semplice constatazione: i principi della sostenibilità, per cui non necessariamente le soluzioni più facili e meno onerose sono le più raccomandabili, valgono anche per le pratiche linguistiche. Lo diamo ormai per scontato per l’ambiente, per l’economia, per i rapporti sociali: ma di sostenibilità linguistica si parla ancora troppo poco. S’inquina, insomma, anche parlando e scrivendo. E parlando e scrivendo si sprecano, si dilapidano e si depauperano risorse, a danno delle generazioni future.
Norme che ricordano quelle autarchiche del nazionalismo linguistico fascista, uno dei sottoprodotti novecenteschi del purismo, bocciato non tanto dalla politica, quanto dalla storia della lingua italiana dell’ultimo secolo
Simili questioni stanno sullo sfondo della proposta di legge, ma vi affiorano in modo purtroppo disordinato e incongruo, per cui in otto brevi articoli capita di rivedere il divieto opposto alle lingue straniere per «sigle e denominazioni delle funzioni» o per «regolamenti interni delle imprese». Sono norme che ricordano quelle autarchiche del nazionalismo linguistico fascista (uno dei sottoprodotti novecenteschi del purismo, bocciato non tanto dalla politica, quanto dalla storia della lingua italiana dell’ultimo secolo). E capita d’imbattersi in istruzioni perentorie e in pene severissime, come quelle dell’ultimo articolo, che par fatto apposta per suscitare titoloni sui giornali: multe da cinquemila a centomila euro. Addirittura. E comminate da chi, e con qual criterio? Chiunque abbia letto Cesare Beccaria o il suo famoso nipote romanziere sa che la minaccia di pene spettacolari è spesso tipica di chi non vuole o non sa risolvere i problemi. Perché sa solo fare la voce grossa. Misure a effetto, insomma. E a questo rischiano forse di ridursi simili proposte: agli stentorei ruggiti di un gatto.
Quanto di emendabile e di evidentemente ancora incongruo vi sia nel testo che abbiamo davanti è chiaro, ancora, nella proposta finale di costituire un Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana sul territorio nazionale e all’estero. L’idea ricorda da vicino quella presente nella proposta del 2018, e in varie altre recenti: quella di un Consiglio Superiore della Lingua italiana con funzioni consultive e di promozione in Italia e all’estero del patrimonio linguistico. L’idea è in sé opportuna, e meriterebbe di essere discussa seriamente e attuata cum grano salis. Ma è difficile immaginare come questo comitato possa essere simultaneamente «presieduto [sarà forse: composto?] da rappresentanti dell’Accademia della Crusca, della Società Dante Alighieri, dell’Istituto Treccani, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Università». A proposito di università: giusto l’istruzione avanzata e la ricerca scientifica sono oggi, di fatto, tra i settori in cui più vivacemente si osserva lo smantellamento dell’italiano di cui si diceva sopra. Per ragioni comprensibili, ma non necessariamente giustificabili, e nel quadro di una tendenza globale, interi settori della riflessione teorica e dell’innovazione tecnica stanno movendo senza esitazioni verso l’istaurazione di un monolinguismo globale il cui unico precedente è l’universalismo latino della cultura medievale. Non solo in molte discipline si pubblica ormai quasi solo in inglese, ma di molte branche della scienza e della tecnica gli stessi esperti sono ormai spesso incapaci o poco capaci di spiegare le proprie conoscenze in lingue diverse dall’inglese (quindi persino nella propria lingua materna).
A quali conseguenze sociali e culturali esponga questa tendenza e a quali clamorose e inedite forme di disuguaglianza e di privilegio essa apra la strada lo stanno cominciando a capire gli ancor rari studiosi dell’intersezione tra scienze del linguaggio e scienze politico-sociali ed economiche. Tale nascente sensibilità, del resto, rischia di essere soffocata dallo strapotere di settori in cui l’attenzione al tema della sostenibilità linguistica è sostanzialmente assente, così come vi è stata a lungo marginale qualsiasi preoccupazione per l’ambiente e la sua tutela. La lingua italiana rischia, anche da questo punto di vista, di non finire nelle mani più adatte a tutelarla.
[Questo articolo è stato modificato in data 11.4.2023]

Riproduzione riservata