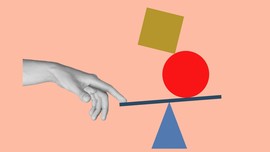Le parole con cui la presidente Meloni dichiara finita l’era dell’“amichettismo” e annuncia l’aprirsi dell’età del merito hanno suscitato, come sempre accade con le trovate provocatorie, una pronta ondata di critiche, per poi finire più o meno nel dimenticatoio.
Peccato, perché poteva essere una buona occasione per riflettere su un problema serio che affligge, e non da oggi, la nostra vita pubblica. La premier se l’è presa con ciò che considera una cattiva abitudine dei governi che hanno preceduto il suo (per comodità polemica considerati tutti “di sinistra”): il vezzo di nominare nei posti che contano gli “amichetti” del decisore facendo valere la tessera conforme che hanno in tasca o quantomeno la disponibilità a prenderla, almeno metaforicamente: adesso lei non consentirà più comportamenti simili, perché è ora di far spazio al merito.
Banale la reazione degli accusati: negare di averlo fatto (con ben poca credibilità), sostenere che anzi essi si sono sempre fatti guidare dalla scelta in base al merito e, soprattutto, mostrare, senza alcuna fatica, che quanto a nominare amichetti il governo in carica non sarebbe secondo a nessuno.
La serietà della questione sta nel fatto che, inevitabilmente, chi governa deve nominare persone in posti di responsabilità. Alle origini del nostro sistema repubblicano per evitare la designazione degli “amici” si era imposto il sistema del concorso pubblico che avrebbe dovuto garantire l’equa valutazione del merito. Difficile non riconoscere che il meccanismo è stato tranquillamente bypassato: certo anche con la corruzione, comunque perseguibile trattandosi di un reato, ma assai spesso con la costruzione di clausole più o meno ad hoc,di profili tagliati sul candidato che si vuole favorire, di prove che facilitano la vittoria di chi si vuole sistemare (cose difficili da sanzionare).
La serietà della questione sta nel fatto che, inevitabilmente, chi governa deve nominare persone in posti di responsabilità
A fronte di questo si è preferito, almeno per posizioni apicali o per incarichi fiduciari, lasciare alla discrezionalità del selezionatore la libertà di scegliere sulla base di quelli che erano i requisiti per una determinata posizione. La discrezionalità, con vari stratagemmi e con qualche sfrontatezza, si è imposta come metodo largamente praticato e accettato.
Eppure una riflessione su come gestire il tema della distribuzione degli incarichi e dei posti si dovrebbe imporre proprio perché è impossibile che si rinunci a questa funzione, a meno di non voler sottoscrivere le prospettive balzane di chi suggerisce che il miglior metodo per risolvere le problematiche sia l’estrazione a sorte dei prescelti.
Per orientarsi in questo campo sarebbe necessario analizzare nei dettagli l’argomento di cui vorremmo parlare. Infatti nelle designazioni che competono a chi esercita un qualche tipo di potere si dovrebbero distinguere tre tipologie.
La prima riguarda le posizioni fiduciarie, dove è ipocrita immaginare scelte che non rispondano al criterio della affidabilità: nessuno sceglie come segretario, cameriere, braccio destro o sinistro che sia, qualcuno di cui non ritenga di potersi “fidare”. Certo se colui che sceglie non è stupido si orienterà verso un “fido” che sia anche il più competente possibile, visto che in definitiva dovrà poi rispondere del lavoro che questi farà per lui. Se sceglie semplicemente basandosi sulla fedeltà e magari sull’adulazione o sul servilismo, prima o poi finirà travolto dalle sue stesse scelte.
In questi casi il profilo dei collaboratori che il leader sceglie consente di giudicare il leader stesso, cioè aiuta a distinguere le autentiche personalità politiche dagli avventurieri e dai dilettanti. Vale per tutte le personalità al di là delle singole collocazioni ideologiche: in tutte le sfumature dell’arco politico si trovano persone di un tipo e dell’altro. Il tema importante sarebbe educare i cittadini a valutare queste scelte in ordine alla distribuzione del proprio consenso: se un personaggio politico si rende conto che scegliere male i collaboratori lo squalifica e mina la sua possibilità di raccogliere voti, si guarderà dal farlo (se sarà così stupido da non capire il meccanismo, ne pagherà il prezzo).
La seconda tipologia riguarda ciò che si dovrebbe chiamare, risuscitando una vecchia categoria storica, “nepotismo”. Consiste nel destinare a posizioni “redditizie” propri congiunti o soggetti con cui si ha un qualche genere di legame affettivo, anche in senso lato. In questi casi al prescelto non vengono affidati compiti di qualche rilievo, non potrà fare azioni veramente significative, sarà semplicemente messo in condizione di fruire di un reddito, più o meno significativo, senza grande fatica (in età tardo medievale e moderna erano i famosi “canonicati”, che peraltro a volte erano usati per mantenere uomini di lettere o di studio).
Questo meccanismo funziona se i beneficati non si fanno troppo notare e se il designatore è abile nel mescolare nomine nepotiste con altre guidate dalla scelta di competenze, in modo che il sistema possa sopportare senza grandi costi i “favori” elargiti. Anche qui siamo in presenza di un fenomeno abbastanza diffuso a tutte le latitudini ideologiche, che però non regge se se ne abusa. Solo una diffusa capacità sociale nel sanzionare moralmente il nepotismo può fare da argine alle tentazioni predatorie che sono sempre presenti nell’esercizio del potere.
Solo una diffusa capacità sociale nel sanzionare moralmente il nepotismo può fare da argine alle tentazioni predatorie che sono sempre presenti nell’esercizio del potere
Veniamo così alla terza tipologia, quella che dovrebbe maggiormente interessare chi ha a cuore la tenuta in equilibrio di un sistema. Si tratta di quelle figure che genericamente potremmo definire alti gradi dell’amministrazione e dei servizi per le quali spesso usiamo, e non è un caso, definizioni prese da altre lingue come grand commis oppure civil servant: personalità che si sentono al servizio del sistema nel suo complesso, vorremmo dire della “costituzione materiale” che regge una comunità politica. Quanto a costoro, non dovrebbe essere necessario chiedere fedeltà personale al referente politico pro tempore, perché si dovrebbe poter contare su una comune fedeltà al sistema da parte tanto del politico quanto dell’alto dirigente amministrativo. Ciò pone ovviamente una questione ulteriore, vale a dire il dovere per quest’ultimo di tenersi fuori dall’agone della competizione politica: qualcosa che nel nostro costume è poco diffuso, anche se sarebbe ingiusto dire che sia totalmente assente. Del resto la classe politica è in generale, ma specialmente oggi, poco simpatetica coi civil servant autentici: non a caso si noterà che la definizione di qualcuno come “tecnico” lo fa sembrare sospetto a chi fa parte della classe politica, anche di quella di terza fila che coopera a cercare di screditarlo presso l’opinione pubblica.
Tutto il quadro che abbiamo cercato di descrivere pone un problema cruciale in tutti i tempi, ma specialmente in quelli di transizione come è il nostro: se non si riesce a costruire un contesto di moralità pubblica e di valutazione dei ruoli nodali nella gestione del sistema politico e sociale ci si priva delle articolazioni funzionali necessarie per affrontare le esigenze a cui deve rispondere una comunità di destino. È qualcosa che va costruito collettivamente da una opinione pubblica responsabile, sottraendolo alle diatribe della politica politicante che tutto sommato non ha grande interesse al riequilibrio del nostro sistema, visto che nei suoi squilibri molti hanno fatto il loro nido.
Denunciare l’amichettismo, ovviamente sempre quello degli altri, e invocare il riconoscimento del merito nella presunzione che tanto potrà farlo a sua discrezione chi denuncia, non serve a molto. È un falso problema che serve a distrarci da quelli veri.

Riproduzione riservata