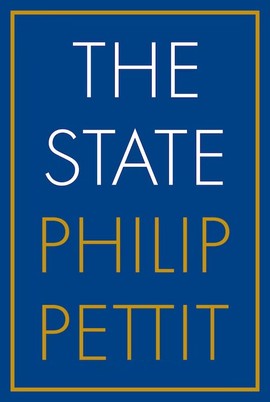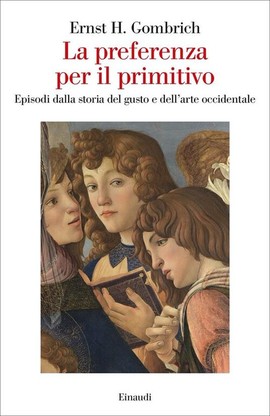Quale funzione spiega l’esistenza dello Stato? A quali condizioni può meglio esercitarla? Che limiti quella funzione pone al riconoscimento di poteri collettivi o diritti individuali in capo ai cittadini? Che limiti all’intervento nel mercato? Queste le domande che affronta l’ultimo libro di uno dei più autorevoli teorici neo-repubblicani, Philip Pettit (The State, Princeton University Press, 2023; la traduzione dei passi citati è mia).
Un libro monumentale, lineare, paziente. Conosco troppo male la letteratura nella quale interviene per collocarlo con sicurezza in quel grande affresco, quindi mi limiterò a un resoconto dei principali anelli della catena di argomenti che Pettit ha costruito.
Devo anche premettere che il repubblicanesimo di Pettit, Quentin Skinner e altri mi ha colpito e convinto: ma ho potuto mettere questa mia inclinazione da parte perché qui riassumo una teoria dello Stato «funzionale», non dello Stato «giusto». Questo sarà il tema di un altro libro, che Pettit annuncia in The State, e che verosimilmente riprenderà la teoria della giustizia che egli deriva dalla concezione della libertà come non-dominazione.
La domanda che anima The State è preliminare a ogni riflessione sulla giustizia: data la funzione che esso effettivamente svolge, può lo Stato essere (anche) strumento di giustizia? Perché la giustizia sarà un’aspirazione realistica solo se la forma di regime politico che ora domina il globo è in grado di promuoverla.
Genealogia delle regole: convenzioni, norme sociali, leggi. «Immaginate un mondo prepolitico» (p. 16). Questo è l’esordio dell’esperimento mentale che Pettit propone, una «genealogia controfattuale» dello Stato. Ma se l’avvio è simile a quello dei teorici del contratto sociale – Hobbes, Locke e Rousseau, che Pettit discute diffusamente – lo svolgimento è diverso. The State si chiede se sia «robustamente probabile» – ossia probabile dentro un vasto spettro di circostanze, e non solo in presenza di condizioni favorevoli – che lo stato di natura evolva in un regime politico simile allo Stato moderno, e quale funzione ne spieghi la nascita e la persistenza.
Le persone che popolano quel mondo prepolitico sono come noi – attente al proprio interesse individuale, moderatamente razionali, dipendenti l’una dall’altra – e vivono in condizioni di relativa scarsità di risorse e approssimativo equilibrio di potere. Quest’ultima condizione, precisa Pettit, può essere vera per tutti o anche solo per una minoranza della popolazione (i più forti, per esempio, che saranno tutti similmente forti).
Pettit sostiene che in simili condizioni l’accumulazione di soluzioni non pianificate a ricorrenti problemi di coordinamento – guidare sulla sinistra o sulla destra, per esempio – darà gradualmente luogo a «vantaggiose regolarità collettive», che col tempo si cristallizzeranno e saranno riconosciute e trasmesse di generazione in generazione come convenzioni vigenti nella società. In modo egualmente spontaneo emergeranno anche delle norme sociali, ossia regole che, a differenza delle convenzioni, può essere gravoso rispettare (dire la verità, per esempio, o rispettare la parola data). Ed emergeranno perché l’imperativo della cooperazione, imposto ai membri della società dalla loro reciproca dipendenza e dalla scarsità delle risorse, rende ciascuno attento alla propria reputazione e vulnerabile all’esclusione.
Le norme sociali tendono però a essere vaghe, di difficile applicazione e incapaci di adattarsi tempestivamente a un mutamento delle circostanze. Nella concezione di Herbert Hart, che Pettit riprende, questi difetti delle norme sociali spiegano l’evoluzione verso un vero sistema giuridico. Perché quei problemi di applicazione e adattamento riceveranno svariate soluzioni ad hoc, dalla cui sedimentazione emergeranno simili regolarità vantaggiose, che gradualmente si condenseranno in un sistema di regole – che Hart chiama «secondarie» – capace di assicurare la precisazione, attuazione ed evoluzione delle norme sociali originarie. Ciò crea un sistema giuridico che verosimilmente sarà accettato da tutti – o quantomeno da tutti i membri della minoranza privilegiata – in ragione della sua capacità di coordinare le aspettative individuali e facilitare la cooperazione sociale.
Genealogia e funzione dello Stato. Lo Stato non è ancora sorto, né secondo Pettit la sua esistenza è necessaria affinché sorgano le regole. Esso emergerà parallelamente a esse, a esito di un simile processo di sedimentazione e integrazione di risposte non pianificate a problemi ricorrenti, dal quale si distaccheranno regolarità vantaggiose che poi si cristallizzeranno.
Così nascerà uno Stato rudimentale, con un qualche meccanismo per chiarire e modificare le leggi, per eseguirle nee per accertare la loro violazione; ed è altrettanto «robustamente probabile» che questo regime politico si avvicinerà progressivamente alla figura dello Stato moderno, perché i medesimi fattori che ne hanno determinato la nascita lo spingeranno a darsi anche i mezzi per sanzionare coercitivamente le violazioni della legge, per affermare il proprio monopolio sull’uso della forza dentro un territorio definito, e per difenderlo da minacce esterne.
Questa genealogia suggerisce che la funzione minima, essenziale dello Stato sia quella di stabilire «un sistema giuridico coercitivo e territoriale che governi le relazioni reciproche tra i cittadini», e difenderlo da minacce interne o esterne (p. 318). Questa funzione «nomotetica» spiega la nascita e la persistenza di questa forma di regime politico.
Conviene sottolineare tre tratti dello Stato, tutti legati a quella funzione. I suoi cittadini di pieno diritto possono ridursi a una minoranza privilegiata, che può essere tanto ristretta quanto lo era la classe «[de]i baroni coi quali il Re Giovanni firmò la Magna Carta» (p. 5). Ma i cittadini devono essere trattati in modo eguale dallo Stato. Tra essi e i governanti deve esistere un approssimativo equilibrio di potere, che rispecchia l’equilibrio che esisteva nello stato di natura (tra i più forti, nel mio esempio). E i cittadini devono avere una ragione per rispettare la legge che sia indipendente dal mero timore della sanzione (ragione rappresentata dal vantaggio derivante dal coordinamento delle aspettative – e quindi dal grado di cooperazione – che la legge assicura).
I cittadini devono avere una ragione per rispettare la legge che sia indipendente dal mero timore della sanzione
Questa nozione dello Stato «funzionale» pertanto esclude regimi che si reggono sul puro terrore, o nei quali il potere della famiglia o fazione dominante è irresistibile, perché in capo ai cittadini svanirebbe quella ragione di rispettare la legge che è indipendente dal timore della sanzione. Ma include regimi che molti qualificherebbero come profondamente ingiusti, come appunto una monarchia medievale. La nozione che Pettit delinea pare dunque coerente con la sua intenzione di presentare una teoria «realista» dello Stato; e dove essa accoglie il principio di uguaglianza, ossia tra i cittadini di pieno diritto, la giustificazione è strettamente funzionalistica.
Lo Stato funzionale quale attore unitario, policentrico e sovrano. Il coordinamento delle aspettative sarà tanto più efficace quanto più le leggi saranno uniformemente applicate e coerenti tra loro. Pertanto lo Stato svolgerà tanto meglio la sua funzione nomotetica quanto più parlerà «con voce univoca» tramite i suoi vari organi (così non era nell’Atene classica, per esempio); e ciò indurrà lo Stato a costituirsi quale attore collettivo unitario, erigendosi a rappresentante autorizzato dei cittadini (come immaginava Hobbes, e prima Bartolo).
Similmente, lo Stato svolgerà tanto meglio quella funzione quanto più la sua voce sarà uniformemente rispettata, sia dai cittadini sia dai propri organi. Da ciò discende una giustificazione funzionalistica anche per il principio della «rule of law», che tradurrei in «supremazia della legge», e per il principio che i cittadini devono poter chiamare lo Stato a rispondere delle proprie azioni.
Costituire lo Stato quale attore unitario accresce però il rischio che i governanti abusino del proprio potere, nuocendo al coordinamento delle aspettative dei cittadini. Da ciò una ragione funzionalistica per preferire lo Stato policentrico, infine, nel quale i poteri siano divisi e condivisi in un gioco di reciproci bilanciamenti.
Riprendendo qui la tradizione della costituzione mista, Pettit la difende dalle obiezioni del pensiero assolutista – di Bodin, Hobbes, Rousseau, e anche di quei «neo-populisti» contemporanei che vogliono che il governo eletto dal popolo non subisca interferenze da altre autorità pubbliche (p. 115). L’ordinamento policentrico non è incompatibile con la sovranità dello Stato, sostiene Pettit, perché non occorre che il sovrano sia un singolo, concreto organo dello Stato. La voce che i cittadini considereranno sovrana è quella generata dal funzionamento complessivo degli organi dello Stato: in un ordinamento policentrico, il sovrano «non è niente di più o di meno dello Stato stesso» (p. 156).
I poteri collettivi dei cittadini. La critica del pensiero assolutista investe poi la tesi che ai cittadini non può essere concesso il potere costituzionale di sfidare collettivamente il sovrano, avanzando proteste o pretese. La premessa di questa tesi è l’idea che il sovrano debba essere una singola e concreta autorità pubblica, come appena ricordato, e debba avere un potere «incontrollato»: perché ammettere che i cittadini contestino il sovrano implica la necessità di un attore terzo, che decida la controversia, ma che potrebbe a sua volta essere contestato, innescando un regresso all’infinito. L’obiezione assolutista è quindi propriamente «concettuale».
Pettit la incrina, rilevando che almeno un potere di contestazione – la disobbedienza civile: violare deliberatamente una legge ritenuta ingiusta accettandone le conseguenze – è insito nell’ordinamento e pertanto insopprimibile. La smonta, argomentando che in un ordinamento policentrico, nel quale il sovrano è lo Stato, la contestazione dei cittadini interviene nel gioco dei suoi organi, che può accomodarla senza regressi all’infinito. E la supera, affermando che esiste un’ovvia ragione funzionalistica per concedere ai cittadini efficaci poteri di contestazione: accrescere «la pressione sui pubblici ufficiali a essere fedeli alla Costituzione» (p. 221).
Almeno un potere di contestazione – la disobbedienza civile: violare deliberatamente una legge ritenuta ingiusta accettandone le conseguenze – è insito nell’ordinamento e pertanto insopprimibile
Pettit discute anche la contestazione extra-costituzionale, che solleva altre obiezioni concettuali (come possono i cittadini agire collettivamente senza costituirsi in attore collettivo unitario? Su quale Costituzione si fonda il potere costituente?); riassumo solo la conclusione, ossia che così come i cittadini sorreggono congiuntamente lo Stato con la propria adesione, così essi possono congiuntamente ritirarla.
I diritti dei cittadini. In tema di diritti soggettivi gli interlocutori di Pettit sono i libertari, e Robert Nozick in particolare, e più in generale i sostenitori dell’esistenza dei diritti naturali (diritti che ciascuno avrebbe indipendentemente da ogni norma o legge). Se tali diritti esistessero, lo Stato tipicamente li violerebbe o restringerebbe (tassando i nostri redditi, per esempio). Essi quindi rappresenterebbero un limite «metafisico», che permetterebbe solo lo «Stato ultra minimo» che Nozick preferisce (quello che si limita a proteggere i cittadini dalla violenza, il furto e la frode).
Rifacendosi a Hobbes e Bentham, Pettit ritiene che i diritti naturali siano un costrutto teorico «stravagante», difficile da «prendere sul serio» (pp. 245 e 331). In ogni caso, essi sono incapaci di circoscrivere le funzioni e azioni dello Stato nel senso proposto dai libertari, perché indeterminati.
Pettit sposa una teoria «istituzionale» dei diritti, che li concepisce come un prodotto della legge; ed è da questa prospettiva che si chiede se uno Stato funzionale possa concedere ai cittadini un «significativo» spettro di diritti soggettivi senza compromettere la propria funzione nomotetica. La risposta è positiva, naturalmente, perché tali diritti delineano per ciascuno una «secure zone of personal discretion» (p. 262: ossia un’area nella quale la discrezionalità individuale può essere esercitata con sicurezza), e la funzione di coordinamento delle aspettative richiede che ogni cittadino riceva i medesimi diritti; i diritti quindi creano una «zone of civic security» (p. 333) nella quale la cooperazione sociale è facilitata.
La giustizia e il mercato. Come nel caso dei poteri collettivi dei cittadini, nello Stato funzionale i loro diritti possono certamente essere inferiori a ciò che richiederebbe una qualsiasi plausibile teoria della giustizia: ma non esiste obiezione funzionalistica ad accrescerli, Pettit conclude.
Egli confuta anche una limitazione «empirica» all’azione dello Stato: quella sostenuta dai teorici del laissez-faire, secondo i quali l’intervento pubblico nel funzionamento del mercato ha tipicamente effetti indesiderabili. Non è solo per mancanza di spazio che non riassumo gli argomenti di Pettit, che sicuramente arricchiscono il dibattito apertosi nell’ultimo quindicennio, ma anche perché è soprattutto su questo terreno che sarà interessante osservare la congiunzione tra questa teoria dello Stato funzionale e l’annunciata teoria dello Stato giusto.

Riproduzione riservata