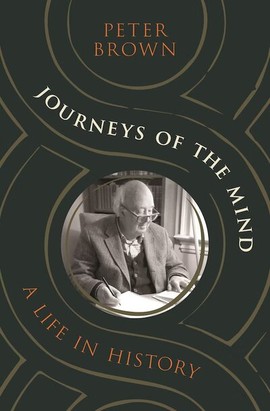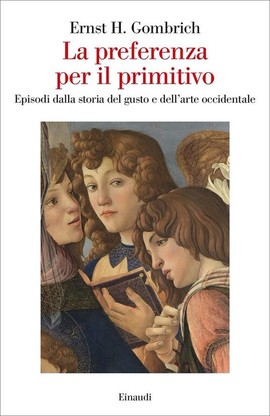Nel 1943, in piena Seconda guerra mondiale, Peter Brown aveva otto anni ed era appena entrato nel convitto di Aravon a Bray, una cittadina sulla costa orientale dell’Irlanda, una ventina di chilometri a sud di Dublino. Aravon era una scuola privata protestante relativamente selettiva, e gli studenti ammessi lì – allora solo maschi, dai sette ai tredici anni – facevano una vita, se non agiata, certamente privilegiata rispetto ai loro coetanei che frequentavano le scuole pubbliche. Nonostante le circostanze tutto sommato tranquille, anche i bambini di Aravon sentivano gli effetti della guerra, che del resto aveva scombussolato la vita dei loro genitori. Parlando degli anni passati nel convitto, Brown racconta che le stanze dove gli studenti dormivano erano tappezzate di ritratti di ex-allievi. I ritratti di quelli che avevano prestato servizio nell’esercito britannico contenevano il nome dello squadrone a cui erano appartenuti. Ai ritratti degli ex-allievi morti in guerra era riservato un ulteriore riconoscimento: il distintivo del loro reggimento era attaccato vicino al nome, alla testa del ritratto. “Ben presto”, scrive Brown, “le pareti si coprirono di distintivi”, e tra gli studenti si diffuse l’idea che trovarsi assegnato un letto vicino a un muro particolarmente denso di distintivi “portava sfortuna”. Non sappiamo dove esattamente Brown dormisse nel collegio di Aravon, perché Brown non lo dice; il racconto di quei ritratti nei dormitori gli serve, nell’economia della narrativa, per dimostrare che “la morte e la memoria” erano state una presenza importante nella sua vita fin da bambino (p. 51).
La morte e la memoria sono le due protagoniste dell’autobiografia intellettuale di Peter Brown, da poco pubblicata con il titolo Journeys of the Mind. A Life in History (Princeton University Press, 2023). Il libro comincia e finisce con la morte della madre di Brown, e in mezzo – attraverso quasi settecento pagine dense di contenuto ma scorrevolissime e avvincenti alla lettura – Brown racconta l’evoluzione del suo lavoro di storico e la storia della sua vita intellettuale e culturale, a partire dalla nascita nel 1935 (e anche prima; i capitoli iniziali raccontano la storia delle famiglie della madre e del padre di Brown) fino agli anni Ottanta.
Morte e memoria, dicevo, sono i fili conduttori della narrativa (e in fondo gli ingredienti principali di qualunque lavoro di storia), ma il libro non è affatto lugubre. Brown è uno storico non solo per professione; il senso della storia per lui è un modo di vedere la vita, non solo il lavoro. Per Brown, avere senso della storia vuol dire per prima cosa prendere atto che il passato è passato, cioè morto. Per “riportare il passato alla vita”, è necessario avere la “costante consapevolezza di vivere a contatto con un Paese straniero immenso, i cui usi vanno trattati con rispetto dai viaggiatori che vengono dal presente”. “Le aspirazioni, paure e certezze” degli abitanti di questo Paese straniero e strano possono “sembrarci aliene” e apparire “sbiadite” dal tempo, ma non bisogna dimenticarsi che “una volta scorrevano nelle vene degli uomini e delle donne del passato con tutta l’energia della vita pulsante” (p. 104).
Per Brown, avere senso della storia vuol dire per prima cosa prendere atto che il passato è passato
È proprio questo rispetto – nutrito da un’infinita curiosità e anche a volte sincera compassione – per le aspirazioni, paure e certezze degli uomini e delle donne del passato che anima il lavoro di Brown fin dall’inizio della carriera. Brown racconta di aver deciso di studiare il tardo antico proprio perché trovava che trattare questo periodo semplicemente in termini di decadenza dell’Impero romano, come la maggior parte degli storici usava fare fino appunto ai suoi lavori, non rispettava la realtà sociale, intellettuale e culturale delle persone che vivevano in quell’epoca. Mettersi nei panni di quelle persone ed essere disposto ad ascoltare quello che le fonti dicevano senza dare giudizi preconfezionati voleva dire rompere (in modo garbato e per niente drammatico, of course) con l’ambiente intellettuale privilegiato, ma anche un po' insulare, provinciale e asfittico di Oxford negli anni Cinquanta e Sessanta, dove il dovere di apparire brillanti in conversazione non sempre creava le condizioni ideali per studiare seriamente e incoraggiava invece un certo pressappochismo di élite.
Anche se Brown, con immensa eleganza, è molto più incline a riconoscere le opportunità piuttosto che le difficoltà degli anni di Oxford, si capisce che non deve essere stato facile per Brown seguire il suo istinto (specialmente quando nessuno – a cominciare da Peter Brown stesso – sapeva che Peter Brown sarebbe diventato Peter Brown). I risultati di questo coraggio sono ovviamente noti a tutti: i saggi di Brown – dalla magnifica biografia di Sant’Agostino fino ai lavori sulla santità, la sessualità, la povertà – hanno cambiato per sempre il modo di vedere il tardo antico. Non più tramonto dell’impero e trionfo della superstizione e della repressione, ma un periodo vitale e vivace, complesso, capace di mantenere legami importanti con il passato ma allo stesso tempo aperto a nuove realtà, fluido. Il contesto che Brown è capace di abbracciare è largo; oltre all’Occidente cristiano, include anche la Persia sasanide e il mondo islamico.
Journeys of the Mind mette il lettore in condizioni di vedere la genesi di tutte queste opere, e allo stesso tempo dà l’occasione di vedere Brown crescere quasi a vista d’occhio: studente e poi studioso, insegnante, collaboratore e poi maestro e fondatore di un vero e proprio campo di studi. Il libro è un’autobiografia, ma l’eroe-protagonista è tutt’altro che solo. Brown è generosissimo nel dare credito (professionale ma anche esistenziale) a tutte le persone con cui ha vissuto e lavorato, e la sua generosità regala al lettore dei ritratti indimenticabili di persone completamente diverse: da Laurence LeQuesne (uno degli insegnanti di Brown al liceo, a cui Brown attribuisce il merito di avergli “trasmesso un acuto senso del passato” e che “ridacchiava come un gentiluomo dell’Inghilterra edoardiana messo di fronte a qualche assurdità particolarmente gradevole”, pp. 102 e 97) ad Arnaldo Momigliano (a cui Brown dedica pagine acute e toccanti, pp. 661-671) alle magnifiche zie Mai (“Zia Mai era fatta di granito”, p. 65) e Freda (che nel lessico familiare di Brown era chiamata “Teedah”, la zia “dolce che sapeva stare al mondo”, p. 67). Mai e Teedah sono due facce della borghesia protestante irlandese novecentesca, solida, saggia e dignitosa (ma anche un po' settaria, per ragioni più che comprensibili), che Brown a tutt’oggi immagina come lettrici di riferimento dei suoi libri – visto che tutti i saggi di Brown riescono a comunicare delle idee complesse ed erudite in una prosa godibilissima, a nome dei lettori ringrazio pubblicamente le zie.
Brown è generosissimo nel dare credito a tutte le persone con cui ha vissuto e lavorato, e la sua generosità regala al lettore dei ritratti indimenticabili di persone completamente diverse
Oltre alle persone, il libro di Brown è molto attento ai luoghi. Brown scrive pagine splendide sui posti in cui ha vissuto (dall’Irlanda a Oxford e Londra, e poi Berkeley in pieno fermento post-sessantottino, fino al santuario bucolico di Princeton) e che ha visitato (il capitolo che racconta il viaggio in Iran poco prima della rivoluzione ha i colori, le forme e il ritmo di un’epica).
I lettori disposti a seguire i “viaggi della mente” di Brown, insomma, impareranno tante cose non solo sugli sviluppi della storiografia, filosofia e antropologia sul tardo antico, ma anche sulla vita culturale, sociale e politica europea (e non solo) del secondo Novecento, viste dalla prospettiva di un uomo di straordinaria intelligenza, curiosità e capacità di guardare e ascoltare senza sputare sentenze. Tra le tante lezioni del libro, forse la più importante, a mio avviso, è proprio questa: nel mestiere di storico come nella vita, a mettersi nei panni degli altri (che siano vivi o morti) si impara sempre qualcosa.

Riproduzione riservata