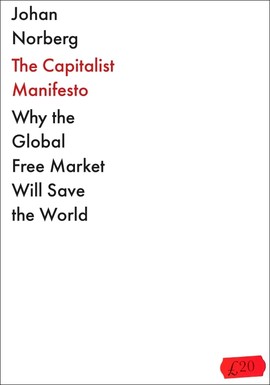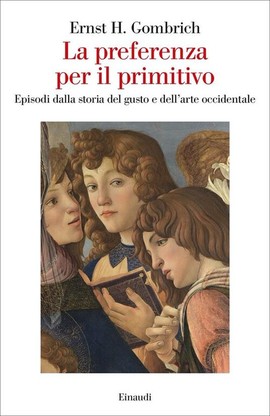Con The Capitalist Manifesto: Why the Global Free Market Will Save the World (Atlantic Books, 2023), Johan Norberg si pone l’obiettivo di rispondere alle critiche che negli ultimi quindici anni sono riemerse nei confronti dell’ordine economico occidentale o, come viene chiamato dai suoi detrattori, “neoliberismo”. Quest’ultimo è accusato tra le altre cose di incrementare le disuguaglianze, accentrando la ricchezza nelle mani di pochi, nonché di essere la causa principale del cambiamento climatico.
Ebbene, il tentativo di Norberg, senior fellow presso il think tank libertarian statunitense Cato Institute, fallisce miseramente. Il volume è scientificamente debole, pieno di inesattezze – per usare un eufemismo – dal punto di vista storico, nonché decisamente mal argomentato. In particolare, unendosi in questo a un’abitudine di pigrizia intellettuale che è ormai tristemente condivisa negli ambienti neocentristi, fa un ampio uso della fallacia logica dello “straw man argument”, espediente che consiste nel confutare un argomento proponendone una rappresentazione errata o distorta.
Il mondo è così presentato come un contesto bipolare: capitalisti da una parte, “populisti” dall’altra. Ogni sfumatura, ogni problematizzazione è spazzata via. Gli economisti Mariana Mazzucato e Thomas Piketty, critici “da sinistra” non certo dell’economia di mercato ma dei suoi eccessi, vengono accomunati a Donald Trump, a Hugo Chávez e all’associazione francese Attac in una sorta di fittizia “internazionale populista” che vede nel libero mercato e nel capitalismo un nemico e nel protezionismo e nello statalismo la soluzione ad ogni male.
Questa banalizzazione non rende certo un buon servizio allo scopo dell’autore, ed è perfino pericolosa come quando, nel presentare il libero mercato e il capitalismo come il Bene, giunge a tessere le lodi dei regimi autocratici di Uganda e Rwanda, che hanno il pregio di aver liberalizzato le loro economie e quindi di aver partecipato alla costruzione della soluzione ad ogni male, la crescita economica. E così come il Male è la mescolanza di differenti – talvolta radicalmente diverse – posizioni, anche quando si tratta di definire il Bene, Norberg confonde deliberatamente tra di loro concetti molto distinti come capitalismo, libero mercato, libero commercio tra Stati, globalizzazione.
Nelle prime 118 pagine si ha il dubbio che l’autore sia semplicemente ignorante. Il lettore giunge però poi – non senza fatica – al capitolo 4, che è di una disonestà intellettuale da mozzare il fiato. È in questo capitolo, intitolato In difesa dell’1%, non a caso indicato da Elon Musk sul suo social network X come quello dal lui preferito, che Norberg dà il meglio – si fa per dire – di sé. Per prima cosa, accomuna i piccoli e medi imprenditori a Musk e agli eredi Arnaud e Ferrero. Gli imprenditori – tutti gli imprenditori! – sono innovatori, geniali inventori, che rischiano il proprio capitale e persino la propria casa, che sacrificano il tempo da dedicare alla famiglia e agli amici, e sono gli ultimi ad essere pagati dopo dipendenti, creditori e fornitori. E quello che resta loro in tasca è solo una piccolissima parte dei ricavi tanto sudati.
Duemilacentocinquantatré persone possiedono di più delle popolazioni di India, Cina, Stati Uniti, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brasile, Bangladesh, Russia e Messico messe insieme
Norberg spiega poi che le nostre vite quotidiane sono molto più simili a quelle dei super-ricchi che a quelle dei nostri trisavoli. Per ridimensionare questa affermazione, vale la pena di ricordare che secondo Oxfam 2.153 miliardari nel mondo posseggono più ricchezze dei 4,6 miliardi di persone più povere del pianeta messe insieme. Duemilacentocinquantatré persone, equivalenti alla popolazione di Pollica in provincia di Salerno, possiedono di più delle popolazioni di India, Cina, Stati Uniti, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brasile, Bangladesh, Russia e Messico messe insieme. Ma va tutto bene, secondo Norberg, visto che in casa nostra c’è il frigo esattamente come in quella di Jeff Bezos, mentre i nostri trisavoli il frigo non l’avevano.
Il capitolo prosegue con un attacco ad personam a Thomas Piketty, l’economista francese che ha portato al centro del dibattito pubblico il tema delle disuguaglianze e della concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi. Dopo aver detto che “capisce i romanzi meglio dell’imprenditoria”, e averlo definito “la caricatura dell’intellettuale francese che siede comodamente nella sua torre d’avorio”, Norberg attacca il punto centrale dell’opera di Piketty, ovvero il fatto che nella storia il rendimento del capitale è sempre stato superiore al tasso della crescita economica (la famosa formula r>g). Piketty ne conclude che anche gli imprenditori che traggono profitto dalle proprie idee e dal proprio lavoro finiscono per diventare “rentier”, ovvero qualcuno che vive non più di lavoro, ma di interessi e rendite. Inoltre, attraverso l’eredità questa diseguaglianza – negativa per la stessa crescita economica! – si tramanda attraverso le generazioni.
Norberg reagisce dicendoci che i risultati di Piketty “sono strani”: altri ricercatori, scrive, trovano che non è vero che la maggior parte della ricchezza sia ereditata, che non è vero che cresca più in fretta dell’economia reale, e che anzi la ricchezza ereditata si riduce per colpa di tasse e filantropia. È quasi superfluo dire che questi “altri studi” sono effettuati da ricercatori del Cato institute, lo stesso think tank libertario per cui lavora Norberg, e non sono stati mai pubblicati su riviste peer reviewed.
Il capitolo si chiude con una lunga riflessione sul fatto che l’eccessiva concentrazione del potere di mercato nelle mani di alcune imprese alle volte avviene davvero, ma quando avviene è perché queste imprese ricevono sussidi statali, fanno donazioni ai partiti politici, ottengono sgravi fiscali facendo lobbying. Questo genere di pratiche viene definito “socialismo per capitalisti”. Quello che Norberg finge di non sapere è che uno dei problemi del concentrare eccessivamente la ricchezza nelle mani di pochi è che si finisce per accentrare nelle loro mani anche il potere politico. E questa cosa non si chiama socialismo, ma è proprio uno dei problemi principali del capitalismo dei “rentier” e della disuguaglianza denunciato da Piketty, Milanovic e altri.
Quello che Norberg finge di non sapere è che uno dei problemi del concentrare eccessivamente la ricchezza nelle mani di pochi è che si finisce per accentrare nelle loro mani anche il potere politico. E questa cosa non si chiama socialismo
A proposito di cambiamento climatico, Norberg inverte causa ed effetto e afferma che, poiché i Paesi più ricchi sono quelli in cui si ricicla di più e quelli più poveri sono quelli che inquinano di più, la soluzione al cambiamento climatico è più crescita, più capitalismo senza regole, e più libero mercato.
Infine, a proposito di politiche industriali, Norberg attacca il concetto di “innovazione orientata alla missione” dell’economista Mariana Mazzucato. Per farlo, non trova di meglio che sostenere che la crescita delle tecnologie informatiche, di internet, dell’energia nucleare, dei vaccini, non sono state sostenute da investimenti strategici, ma sono stati “effetti collaterali” di una spesa pubblica per la maggior parte improduttiva. Sminuendo quindi il ruolo essenziale degli investimenti pubblici, delle regolamentazioni e dei sussidi nei settori in cui il privato non può fare abbastanza profitti nel breve periodo da poter sostenere l’innovazione.
Insomma anche su questo Norberg, nel suo volere a tutti i costi ridurre il mondo e la storia a uno scontro tra Capitalismo e Socialismo, finisce per ridurre le sue stesse posizioni a caricatura, ed è impossibile prenderlo sul serio. Norberg dedica il suo Manifesto “ai liberali classici di tutti i partiti”. Ma i liberali classici del XVIII e XIX secolo (Smith, Stuart Mill, Marshall) erano pragmatici e ragionevoli e riconoscevano il ruolo legittimo dello Stato in un'economia di mercato. Il vero pubblico di Norberg si trova tra i libertari dottrinari, fan di Hayek, Friedman e von Mises, che troveranno conferma ai propri pregiudizi. Chi invece cerca una difesa ponderata del capitalismo neoliberista contro i suoi critici resterà senz’altro deluso.

Riproduzione riservata