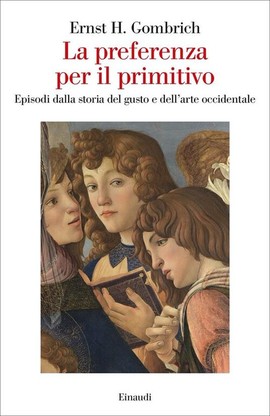Come accade ai tecnicismi meno superflui, “iconotesto” sembra alludere a qualcosa di complicato ed elitario, ma in realtà indica una modalità molto diffusa della produzione culturale: la coesistenza su uno stesso supporto (pagina o schermo che sia) di immagini e di testo, senza che una delle due schiacci l’altra finendo per trasformare l’iconotesto in una raccolta di illustrazioni con qualche didascalia (prevalenza di immagini) o in un testo tradizionale con una manciata di figure (eccesso di scritto). L’iconotesto non va nemmeno confuso con il fototesto, suo discendente diretto, che nasce a fine Ottocento con la diffusione della fotografia e le prime importanti pubblicazioni di Georges Rodenbach (Bruges-la-Morte, 1892) e Jack London (Il popolo degli abissi, 1903). Il senso dell’iconotesto sta nell’equilibrio mobile che crea fra componente visuale e sezione alfabetica, quasi sempre in dialogo fra loro. Con le parole di Lavinia Torti, nel volume Doppie esposizioni. Forme dell'iconotesto italiano contemporaneo (Biblion, 2023), in questa forma s’inscena una “doppia esposizione” che, lungi dall’alludere a una tecnica di sovrimpressione fotografica, rappresenterebbe “la duplice presentazione dell’oggetto-immagine, una volta come riproduzione fotografica, un’altra volta come descrizione ecfrastica” (p. 21). Decifrare le immagini senza tenere in conto la loro interazione con la parola, e in parallelo analizzare i testi ignorando l’iconografia che sottintendono, è in altre parole come vedere un film senza alcun tipo di sonoro, o godere dell’arte solo attraverso fotografie in bianco e nero.
Negli ultimi vent’anni in Italia, complice il rinnovato interesse per la cultura visuale dal Rinascimento (Lina Bolzoni) alla modernità (Michele Cometa), anche l’iconotesto ha ritrovato grande fortuna critica, in particolare negli studi letterari (con le ricerche di Giuseppe Carrara, Roberta Coglitore, Andrea Cortellessa, Luigi Marfé, Maria Rizzarelli e tanti altri). Più di recente, il tema è diventato quasi imprescindibile per chi si occupi di letteratura contemporanea: lo sottolinea Luigi Weber nella premessa a Doppie esposizioni (p. 15), lo prova la ricca, aggiornata bibliografia in calce a questo lungo saggio, che rielabora la tesi di dottorato della giovane autrice (pp. 289-306). Torti si concentra in particolare sull’iconotesto italiano degli ultimi trentacinque anni (capitoli I e III), anche se intervalla l’analisi nel capitolo II con alcuni scavi teorici oltre confine su figure fondative della cultura visuale (Aby Warburg), intellettuali sospesi fra disegno e scrittura (John Berger) e artiste visuali (Sophie Calle). In particolare, la lezione di Warburg e del suo Atlante Mnemosyne (un atlante figurativo in cui Warburg assemblava a suo gusto riproduzioni di opere appartenenti a stili, mani, epoche diverse) è tracciata con esattezza storiografica e individuata come possibile modello per quella linea degli iconotesti italiani contemporanei che indugia nell’autoritratto nel proprio studiolo e nel collezionismo idiosincratico. Ne è un chiaro esempio Autoritratto nello studio di Giorgio Agamben (pp. 211-228): con la differenza non da poco che, laddove l’Atlante di Warburg disponeva una serie potenzialmente infinita di materiali in continua evoluzione, senza un messaggio da trasmettere o una tesi da sostenere, gli atlanti letterari di Doppie esposizioni sono libri conclusi, che seguono un progetto definito in partenza.
Può darsi che la situazione in parte sia cambiata negli ultimi vent’anni di Internet 2.0, con i blog e i social network, dove alcune delle opere di cui si parla in Doppie esposizioni (Antonio Moresco, Francesco Pecoraro) avevano trovato una prima gestazione, fatta di accumulo di materiali eterogenei e di ibridazione testo-immagine. Ma questo è un altro discorso, che Torti accenna nelle conclusioni (L’ipertesto è esposto, pp. 283-287) quando medita sul riuso costante delle immagini a cui è portato ciascuno di noi, in un circuito della comunicazione più digitale, egoriferito e smemorato che mai.
Gli atlanti letterari di Doppie esposizioni sono libri conclusi, che seguono un progetto definito in partenza
In una prima sezione di Doppie esposizioni si fa lo stato dell’arte e si ricostruiscono “storia e tipi dell’iconotesto nel Novecento” (p. 101) con uno scrupolo forse ridondante, data la bibliografia già corposa sul tema. Inoltre, alcuni passaggi sull’estremo contemporaneo (pp. 75-93), benché acuti, possono conferire l’impressione di un certo disordine d’insieme, visto che si esaminano iconotesti splendidi come Autopsia dell’ossessione (2010) di Walter Siti, Condominio oltremare (2014) e Flashover (2020) di Giorgio Falco e Sabrina Ragucci, Absolutely Nothing (2016) di Giorgio Vasta e Ramak Fazel; libri così cruciali non avrebbero sfigurato nel capitolo III, consacrato all’ultimo trentennio. Qui sono un po’ sacrificati e un accenno di andirivieni fra testi, secoli, autori si avverte. Tuttavia, man mano che il saggio progredisce, la sua tesi di fondo s’individua abbastanza bene e giustifica la disposizione dei materiali d’esame alla luce di quello che, per Torti, è l’elemento più attrattivo dell’iconotesto. La sua qualità nascosta, relativamente poco studiata in un campo nuovo ma già così battuto, è infatti la possibilità di incarnare un “secondo livello” della comunicazione, di sfuggente onnipresenza, simile a un fantasma. La similitudine è d’altronde il perno dell’argomentazione di Torti, perché il concetto di spettralità sostanzia molti degli iconotesti al centro del capitolo III. Dopotutto la fotografia, secondo le osservazioni classiche di Roland Barthes in La camera chiara (1980), mentre fa presente quello che è morto, spesso ha l’effetto collaterale di rendere spettrale l’esistente, di confondere le barriere fra il reale e l’immaginario: i testi su cui Torti si sofferma rispettano, ciascuno a suo modo, questo doppio mandato. La vita dei dettagli (2009) di Antonella Anedda, Hotel a zero stelle. Inferni e paradisi di uno scrittore senza fissa dimora (2011) di Tommaso Pincio, Asterusher (2015) di Michele Mari e Francesco Pernigo, Le galanti. Quasi un’autobiografia (2019) di Filippo Tuena: in queste opere l’immagine ha una funzione evocativa e destabilizzante che toglie affidabilità anche al resoconto scritto e potenzia l’atmosfera fantastica dei racconti.
Siamo quindi lontani dall’ambizione concreta e cronachistica di altri iconotesti del Novecento, dentro e fuori dalla letteratura, per la quale si può rimandare alla grande tradizione dei reportage su rivista (dall’“Europeo” in giù) ma anche a opere in volume come la riedizione fototestuale del 1953 (di scarsissimo successo) di Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. All’opposto, ci troviamo nello stesso clima culturale di altre opere europee ed extraeuropee come quelle di W. G. Sebald e di Orhan Pamuk, su cui nello stesso capitolo III Torti si sofferma.
In sintesi, la nozione su cui s’impernia Doppie esposizioni è la metapicture: quell’immagine che rimanda a sé stessa, o ad altre immagini, secondo una logica meta-discorsiva
In sintesi, la nozione su cui s’impernia Doppie esposizioni è la metapicture: quell’immagine che, nelle definizioni incrociate di W. J. T. Mitchell in Picture Theory (1995) e di Victor Stoichita in L’invenzione del quadro (1998), rimanda a se stessa, o ad altre immagini, secondo una logica meta-discorsiva. È alla luce della metapicture che si osserva, per esempio, il breve Nel museo di Reims (1988) di Daniele Del Giudice. Uno dei maggiori meriti di Torti sta nel riportare l’attenzione su un libro dimenticato dai discorsi sul presente (come, per certi versi, il suo autore, di cui è appena uscita un’ottima edizione di saggi rari e inediti per Einaudi, intitolata Del narrare), e soprattutto nel contestualizzarlo all’epoca in cui è stato composto. La prima edizione del libro, praticamente introvabile, includeva sedici riproduzioni fotografiche dalle opere dell’artista figurativo Marco Nereo Rotelli, poi espunte da tutte le edizioni successive (pp. 165-175). Se il racconto scritto si svolge come un vagabondaggio onirico dentro l’omonimo museo, con il protagonista che descrive a parole quindici opere d’arte (una tecnica nota col termine greco di ekfrasis), togliere le immagini dal libro ne ha precluso la comprensione corretta, ci ha offerto un testo mutilato. Al contrario, dentro la prima edizione di Nel museo di Reims “la descrizione modifica la ricezione dell’immagine stessa” (p. 175): e, viceversa, l’immagine finalmente riemersa dà nuovo significato alle parole scritte che credevamo di conoscere. Non solo: l’interpretazione di Del Giudice, agevolata da ampie trascrizioni e corredi delle immagini originali, si allarga fino a diventare esemplare di una tensione diffusa dell’iconotesto contemporaneo: quella a raccogliere e catalogare, secondo un proprio ordine privato, i segni del tempo, a ricomporli in una “automuseografia” personale (p. 286). I fantasmi, così, diventano almeno due: da una parte l’autore, che si dissemina in una composizione mobile di autoritratti; dall’altra il lettore, che si aggira, come un visitatore inaspettato, dentro il museo immaginario che l’autore ha fatto, attraverso l’opera, della propria esistenza.

Riproduzione riservata