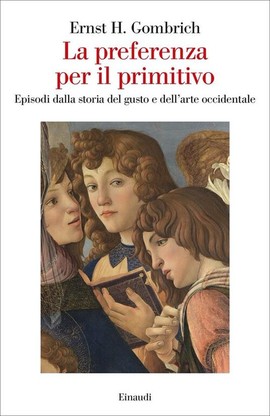L'attentato del 15 marzo 2019, consumatosi nella lontana Nuova Zelanda per mano del suprematista bianco Brenton Tarrant contro due moschee di Christchurch e che ha provocato circa cinquanta morti, basterebbe da solo a dimostrare che l'insistita riconduzione del terrorismo alla sola matrice islamica è una pura operazione ideologica, che ha condizionato il dibattito occidentale negli ultimi trent'anni. Anche per questo il libro di Francesco Benigno (Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica, Einaudi, 2018), ricco di dati ma allo stesso tempo piacevole alla lettura e non specialistico (un saggio a tesi, come suggerisce il sottotitolo, che seleziona le informazioni e opera precise scelte di campo), risulta prezioso per tutti i lettori che vogliano decostruire i processi di essenzializzazione di un fenomeno che non si presta affatto a semplificazioni e facili interpretazioni.
Negli ultimi due secoli, spiega l'autore, terrore e terrorismo sono stati la continuazione della politica con altri mezzi, e per chi voglia comprendere gli scopi e la trasmissione delle tecniche di questa forma di violenza, tesa a condizionare, in un senso o in un altro, i rapporti di forza sociali, occorre attrezzarsi a ripercorrerne la storia. Non le genealogie inventate da una recente produzione sul terrorismo, dominata da rozzezze politologiche e letture faziose allo scopo di antichizzare una prassi in tutto e per tutto moderna. A nulla servirà rispolverare gli antichi sicari di cui racconta Flavio Giuseppe, la setta sciita degli assassini (i nizariti) attiva dopo l'anno Mille, i mitici thugs seguaci della dea Kalì sfruttati in epoca coloniale per offrire un'immagine a tinte forti dell'Oriente indiano. Allo stesso modo, sarebbe fuorviante insistere sui presunti protomodelli religiosi del fenomeno (il martirio, la guerra santa, l'imposizione fondamentalista di una fede), o pensare che si tratti di atti insensati che si qualificano per il fatto di colpire gli «innocenti» (negli ultimi secoli la guerra tradizionale, in misura crescente, ha ucciso senza discriminare eserciti e popolazione civile). Come sottolinea Benigno, in realtà il terrorismo è sorto a partire dal momento in cui in Europa (e non tra i «barbari») sono nate l'opinione pubblica, la rivoluzione e la controrivoluzione. Perché esista il terrorismo (e il contro-terrorismo delle polizie e dei servizi di intelligence, l'altra faccia della medaglia a cui Benigno ha dedicato questo libro, come il precedente La mala setta, che aveva per soggetto la decostruzione della storia della mafia e della camorra nel XIX secolo) occorre qualcuno che combatta per una Causa (l'Uomo Nuovo, la Tradizione, la Nazione, la Rigenerazione) e una controparte che, spesso con gli stessi strumenti, prova a ostacolare un progetto di radicale mutazione dell'ordine, confondendo le acque e affibbiando l'etichetta di terrorista a un nemico che quasi sempre la rifiuta, ritenendosi un militante o un combattente. Molti che onoriamo come eroi – ricorda giustamente il testo –, prima di vincere la loro battaglia, sono stati qualificati come terroristi dalle polizie che li avversavano.
Questa storia, in sostanza, comincia con il terrore giacobino e con la comparsa di questo termine nel fuoco rivoluzionario. In quell'epoca-sella si consuma il netto trapasso dal classico e isolato atto di tirannicidio alla cospirazione progettata, che ricorre alle armi ingaggiando una sorta di guerra asimmetrica con i nemici (una guerra partigiana). In quel momento il terrore di Stato diventa una tecnica di governo che farà le sue prove più efferate nel XX secolo. Benigno tuttavia non si inoltra sul terreno delle pratiche di terrore che la Arendt ha ritenuto tipiche del cosiddetto totalitarismo. Piuttosto, sulla scia di Charles Tilly, traccia un percorso a tappe che comincia con lo stato d'eccezione giacobino, e con episodi celebri come quello di Charlotte Corday, per mettere a fuoco il primo momento di una lunga storia: quello in cui fanno la loro apparizione rivoluzionari professionisti, come il nostro Filippo Buonarroti, e capi di polizia che imparano come infiltrare le sette segrete di stampo sovversivo o reazionario ostacolandone i disegni. Se la prima «autobomba» è quella che cercò di colpire Napoleone mentre si recava a teatro nel 1800 (un carro-botte imbottito ad arte fece ventidue morti per opera di un gruppo controrivoluzionario, ben prima degli episodi novecenteschi raccontati da Mike Davis in un libro di qualche anno fa), dopo l'invenzione della guerriglia nella Spagna anti-rivoluzionaria, invasa dalle divise francesi, sarà un altro italiano, Carlo Bianco di Saint-Joroz, a stilare un manuale di «terrorismo» (1830) che avrebbe colpito un Mazzini in bilico tra violenza e rifiuto delle tecniche e degli obiettivi più estremi di lotta politica. Nell'età delle rivoluzioni nazionali e sociali – ricorda Benigno – l'attentato svolge una crescente funzione di propaganda, e dunque è la città il palcoscenico degli atti più eclatanti del secolo, come quello di Felice Orsini ai danni di Luigi Napoleone. Ma non si tratta solo dell'Europa occidentale o dell'Irlanda cattolica oppressa dagli inglesi: le tecniche del terrore, grazie anche alle emigrazioni, trapassano negli Stati Uniti della guerra civile, nei territori nordafricani colonizzati dalla Francia (dove gli occupanti si attrezzano a formalizzare la contro-guerriglia) e soprattutto nella Russia zarista agitata dal populismo e dall'anarchismo. Nell'alveo della tradizione bakuniana, l'atto di terrorismo diventa così «propaganda con il fatto»; all'interno della violenta costellazione nichilista rappresentata da Dostoevskij ne I demoni, Sergej Nečaev esalta i «fanatici» disposti a uccidere e a immolarsi senza risparmiare nessuno.
Sono le pagine più belle di Benigno, che nell'affresco della Russia di fine Ottocento e dell'internazionale anarchica, come in altri capitoli, mostra la sua sensibilità per la letteratura e per il nodo del rapporto tra rappresentazione, realtà e capacità performativa delle narrazioni (il libro parte citando il Conrad de L'agente segreto). In quell'orgia di attentati che caratterizza la storia dell'Europa tra la fine Ottocento e i primi anni del Novecento, le polizie affinano le tecniche di infiltrazione ed esasperano lo scontro forzando i governi a imporre l'ordine. Poi giunge l'atto terroristico che più di ogni altro ha condizionato la storia: l'assassinio di Francesco Ferdinando d'Asburgo a Sarajevo, nel 1914, ordito in un intrico politico che Benigno prova a districare. La seconda Guerra dei Trent'anni che ne seguì abituò militanti, combattenti e civili a un grado di violenza e terrore inauditi, e il successo della Rivoluzione bolscevica fece il resto (l'autore non trascura di ascrivere alle tecniche di terrore i bombardamenti aerei che fecero la loro comparsa allora).
Ma sono le parti dedicate alla Guerra fredda e alla decolonizzazione quelle in cui l'autore, con più efficacia, illustra come le tecniche di terrorismo, di terrore e di controrivoluzione, in uno scacchiere globale, passino di contesto in contesto, di gruppo in gruppo, di polizia in polizia, dai rivoluzionari ai loro nemici, mutando obiettivi e giocando una parte rilevante nella politica, negli assetti geostrategici e presso l'opinione pubblica. In questa sezione del libro sono analizzati Stay-behind e la Banda Stern, con la nascita di Israele; il maoismo e la Guerra di Algeria, in cui i francesi non esitarono a ricorrere al terrore (teorizzandone l'uso); la Cité Catholique e gli studi di psicologia sociale tesi a comprendere come vincere la guerra per conquistare i cuori delle masse; la Scuola delle Americhe, il Piano Condor e i Lupi grigi in Turchia; la questione palestinese e abili doppiogiochisti come Carlos e Abu Nidal; il maoismo e la guerriglia latino-americana, trapiantati dalle campagne e dalle foreste nei contesti urbani europei e giapponesi durante gli Anni di Piombo. L'ultimo capitolo, l'ottavo, getta poi luce su una storia che ci tocca da vicino: su quella nuova costruzione occidentale del «male assoluto», che surroga il comunismo sconfitto con un nuovo nemico e vede protagonisti la scuola statunitense dei neo-cons allevata da Leo Strauss; il libro sul terrorismo curato da Benjamin Netanyahu nel 1986; le pagine di Bernard Lewis e quelle meno note della giornalista Claire Sterling, che parlò di una rete terroristica unica in un libro del 1981 capace di scatenare la paranoia e di attrarre i circoli della destra Usa. Al tramonto del Novecento, il paradigma vittimario prende il sopravvento, il terrorista diventa quasi una categoria umana a sé e l'islam, dopo la Rivoluzione iraniana, finisce per rappresentare la quintessenza della minaccia globale a cui opporre guerre umanitarie e preventive, stati di eccezione e operazioni di intelligence. «Duplice, obliquo e opaco», come scrive Benigno, il terrorismo si rileva così, grazie anche a questo libro, come «il vero inquietante fantasma del nostro tempo». Non lo spettro marxiano della rivoluzione socialista, ma l'incubo di una violenza che origina da obiettivi politici sempre più difficili da afferrare o da condividere.

Riproduzione riservata