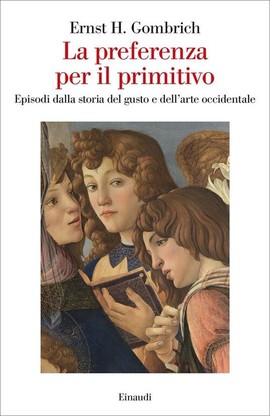«Le invasioni barbariche», per mutuare il titolo di un bel film di qualche anno fa del canadese Denys Arcand, identificano una delle ossessioni più ricorrenti in questo trapasso di millennio. Un’angustia postmoderna, parente stretta dell’angoscia di epoca premoderna, che, a ben guardare, ci dice molto del naufragio del «progetto moderno», con le sue razionalissime e illuministiche speranze di convivenza.
Il nuovo libro pubblicato in Italia di uno dei maggiori studiosi dello «spirito dell’Illuminismo» (oltre che di uno dei più cosmopoliti intellettuali europei), Tzvetan Todorov, racconta, giustappunto, la paura dei barbari contemporanea e, quindi, anche molto di quello che sta, sfortunatamente, diventando la civilizzazione europea, convertitasi, al cospetto delle problematiche epocali suscitate dalla mondializzazione e dai movimenti migratori, in «Fortezza Europa», tra destre xenofobe di ogni genere, pressioni neocon d’Oltreoceano e opinioni pubbliche timorose e disorientate, nelle quali sono state inoculate dosi massicce di «veleno sicuritario».
Partendo da un assunto, che l’autore mette nero su bianco: «La mia ipotesi sarà questa: l’unità della cultura europea consiste nella sua maniera di gestire le diverse identità che la costituiscono a livello regionale, nazionale, religioso e culturale, accordando loro uno statuto nuovo e traendo profitto da questa stessa pluralità. L’identità spirituale dell’Europa non porta ad annullare le culture specifiche e le memorie locali. Non consiste in un elenco di nomi propri o in un repertorio di idee generali, ma nell’adozione di un medesimo atteggiamento di fronte alla diversità» (p. 237).
A riconoscere per la prima volta la pluralità come valore, collegandola in maniera sempre più stringente all’idea di Europa, sono, infatti, i protagonisti della grande epopea dell’Illuminismo, da Montesquieu a Voltaire, per i quali il molteplice, come diremmo oggi, costituisce un incentivo allo spirito critico e uno stimolo all’ampliamento della libertà di pensiero e di giudizio degli individui.
Il filosofo e saggista franco-bulgaro ritorna, così, sulla scena del delitto di due dei Leitmotiv fondamentali della sua opera, che coincidono con il Secolo dei Lumi e con la riflessione sulla tolleranza e la relazione tra le culture, divenuta attualmente, nell’affievolimento o, per meglio dire, nell’esaurimento dello scontro ideologico tra destra e sinistra, una delle principali materie del contendere e l’oggetto per eccellenza del conflitto politico.
Il libro di Todorov ha il pregio, tra i tanti, di porsi come una sorta di utile «grimaldello de costruttivo» rispetto alle nuove, pericolose narrazioni del presente, divenute irresistibili, non a caso, a partire dagli anni Ottanta, quando la globalizzazione è esplosa e si è imposta, praticamente senza alternative, all’insegna di una coloritura strenuamente neoliberista, nella quale tematiche come quella dei diritti umani hanno finito per fornire, contro la loro stessa natura, una nobilitazione a fenomeni come quello dell’«interventismo etico» o – pur non coincidenti – dell’«esportazione della democrazia», che poco o nulla avevano di autenticamente umanitario. O come la patologica «retorica sicuritaria» che ha sfruttato abilissimamente, producendo immense fortune politiche, economiche e militari, le metamorfosi, come le ha definite il filosofo Roberto Escobar, dell’eterno e ancestrale sentimento della paura, utilizzato a man bassa da vari, postmoderni, «imprenditori del terrore», pronti a urlare contro l’invasione dei barbari, assicurando di essere i soli possessori di qualche miracolosa ricetta per arrestarla e riconsegnare così le varie comunità alla loro serenità turbata. Che finivano, tutte, indistintamente, imprigionate nel paradigma della società della sorveglianza che, dall’esercito di telecamere dei quartieri posh della Londra capitale della Cool Britannia blairista alle blindatissime villette a schiera della ricca provincia veneta leghista, ha finito per avvolgere, davvero in modo globale e reticolare, le diverse nazioni occidentali.
Il punto è che la perturbante barbarie, come svela, una volta di più, il pensatore antitotalitario di Memoria del male, tentazione del bene, è una categoria morale, e non culturale: le culture sono cornici descrittive (o frame, come li chiamerebbero gli psicologi americani), prive di connotazione etica, e la civiltà non risiede in esse, ma le trascende, così come fa la barbarie. Il barbaro, dunque, il vero «straniero», è colui che non riconosce l’umanità degli altri, stabilendo gerarchie inesistenti e inaccettabili tra esseri umani, e non quello che proviene da fuori delle colonne d’Ercole dell’Occidente o dall’esterno dei confini della Fortezza Europa (cui, molto correttamente, lo studioso rimprovera una drammatica carenza di politica estera, dovuta, per lo più, a eccessi di sudditanza atlantica).
«Da secoli, gli europei sono portati a coordinare e accordare tra loro ideologie di origine differente» (p. 240), come accaduto con la cultura greca riletta da Roma, o con il cristianesimo inseritosi in corpore vivo sull’ebraismo e, ancora, con i tentativi (in buona parte riusciti) di mélange tra tutte queste correnti di pensiero operati dal Rinascimento. Questa, plurale e complessa, è l’eredità della storia del continente, e qui risiede il deposito più profondo della sua tradizione, affacciatosi, polemicamente, anche in occasione della discussione sulla citazione delle «radici cristiane» nella Costituzione, che, palesemente, ne sono una parte, ma che, proprio per questo, non possono invocare alcuna esclusività nella rappresentanza del patrimonio ideale del Multiverso europeo.
Ma Todorov, per richiamare una semplicistica «categoria» del dibattito politico italiano degli ultimi tempi, non è affatto un alfiere del «buonismo». Difatti, «rinunciare all’intolleranza non significa che si debba tollerare tutto. Per essere credibile, un appello alla tolleranza deve partire da un consenso intransigente su ciò che in una società è considerato intollerabile» (p. 22). E, dunque, il «patto repubblicano» deve prevalere sui costumi e le identità comunitarie, altrimenti finiscono per imporsi la violenza e il caos, con la conseguente disgregazione della società. O con la diffusione delle guerre di religione e degli scontri di civiltà, la formula resa universalmente celebre dall’omonimo libro di Samuel Huntington, la cui fortuna si spiega, non da ultimo, per l’estrema semplificazione e il monocausalismo della sua interpretazione del mondo rimasto orfano della Guerra fredda. Ovvero, lo studioso eletto (a dire il vero, persino al di là della stessa volontà dell’interessato) a profeta e padre ideologico della classe dirigente politica e intellettuale strettasi a coorte intorno a George Bush jr., e impegnata a motivare il restringimento delle libertà individuali, la violazione dei diritti umani, la «legittimità della tortura» e il lungo elenco di nefandezze contenute nello Usa Patriot Act all’insegna della «guerra contro il terrorismo» e della «difesa della civiltà occidentale», che costituisce uno dei principali bersagli polemici di questo libro. Tra il Diritto di Antigone e la Legge di Creonte, non c’è spazio per terze vie, e men che meno per interpretazioni interessate, lesive delle libertà dei cittadini. La legge, infatti, secondo Todorov, deve prevalere sul costume, e la civiltà giuridica dovrebbe costituire sempre la stella polare dei politici e dei decision-makers, confermando quanto il filosofo, allergico nei confronti di qualunque «pia illusione» o di qualsivoglia velleitario e generico invito al dialogo, rimanga un figlio irrequieto, ma fedele, del progetto moderno.
Del resto, a parlare per lui è anche, sempre, la nuda vita, da intendersi, in questo caso, non in chiave biopolitica, ma biografica. Le vicende personali e l’esistenza di Todorov, come lui stesso non si stanca mai di ripetere in ogni occasione pubblica, rappresentano un idealtipico manifesto del meticciato e dell’identità plurima. Una testimonianza vivente della pluralità e del rifiuto dei manicheismi che, ora, il tramonto del Secolo breve semplicemente ci impone, all’insegna non di qualche irraggiungibile utopia, ma, innanzitutto, in nome del realismo e dell’assunzione di responsabilità da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza.

Riproduzione riservata